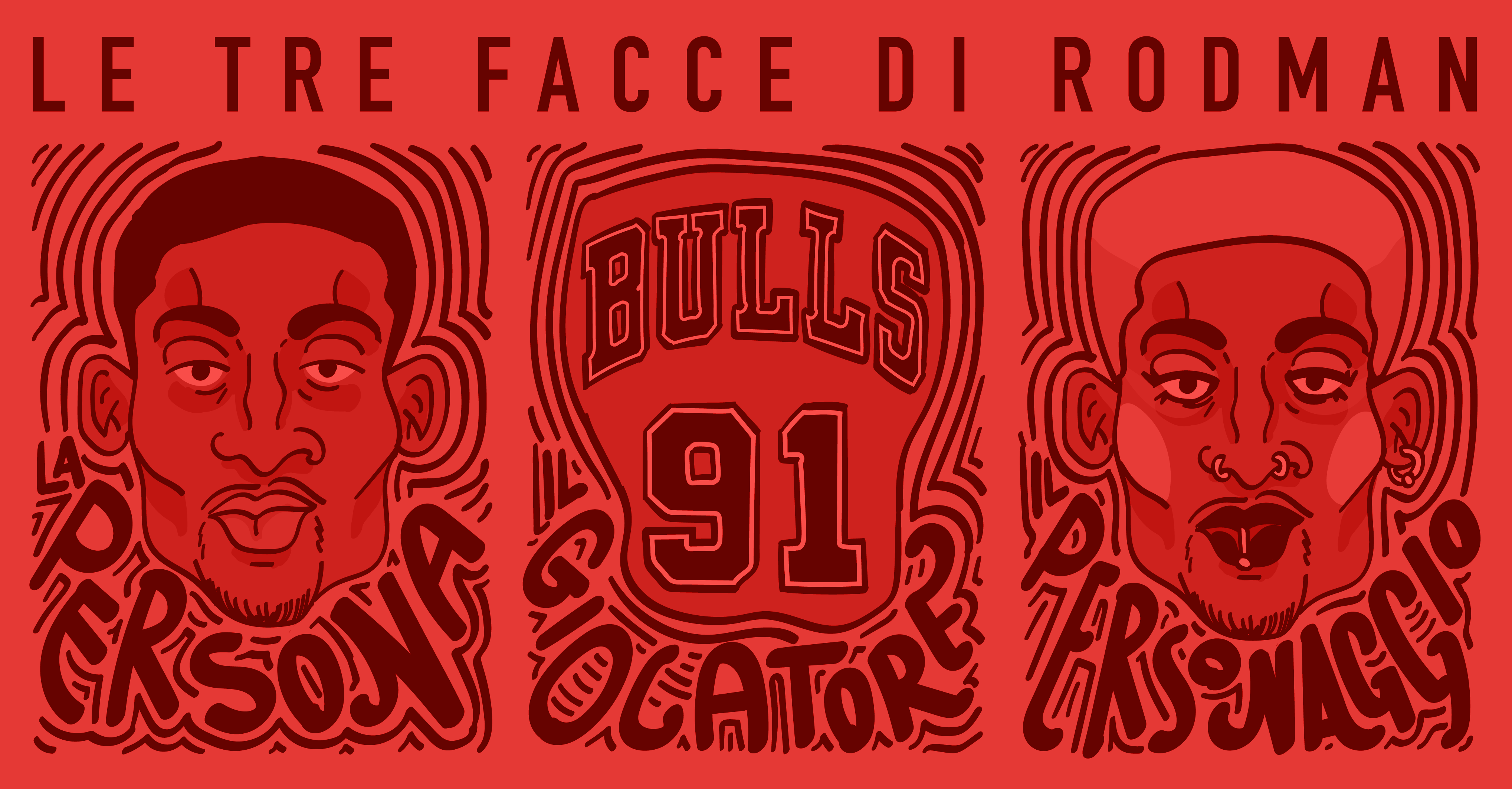“..At center, wearing the big, rough and tough 3! From Vi-rgi-nia U-ni-on U-ni-ver-si-ty…”.
Quante volte, non più tardi di una decade fa, John Mason, iconico speaker al Palace of Auburn Hills, aveva letteralmente galvanizzato la numerosa folla di sostenitori dei Detroit Pistons, con le proprie introduzioni fantasiose e cantilenate. Il pubblico di ‘Motown andava letteralmente in visibilio quando veniva annunciato il capitano della squadra, quello strano centro dalla statura non certo imponente, dal viso imperturbabile e dal folto, immediatamente riconoscibile, afro. Sì, perché la gente di Detroit, abituata alla vita da operai nelle tante fabbriche della città del Michigan, aveva una particolare simpatia innata per quei giocatori, magari non baciati dal talento eccelso, ma in grado di sputare sangue sul parquet, una notte sì e l’altra pure. Per questo, fu amore a prima vista con quel numero 3 che per diversi anni ha difeso il pitturato dei Pistons, conducendoli ad un improbabile quanto meritato titolo NBA. Per questo, fu amore a prima vista tra Detroit e Ben Wallace, uno dei più micidiali stoppatori e rimbalzisti di tutti i tempi.
La storia di Wallace sembra ricalcare il cliché del giocatore-tipo NBA dagli umili natali e che, sgomitando e lavorando, riesce letteralmente a farsi da solo, avendo successo pur provenendo, più o meno letteralmente, dal nulla. Ben, infatti, nacque il 10 Settembre 1974 a White Hall, Alabama, nel Sud degli Stati Uniti. Era il decimo di 11 figli e, come è facile intuire, di pecunia se ne parlava poco e non troppo frequentemente. Cresciuto sotto una rigida educazione ricevuta dalla madre, il piccolo Wallace, sin dall’adolescenza, si rimboccò le maniche, adattandosi a svariati lavori, tra cui quello di barbiere, pur di guadagnare un minimo di dollari da devolvere subito alla nutrita famiglia. Di pari passo in Ben crebbe anche il desiderio di fare sport. Football, baseball e, soprattutto, pallacanestro, nonostante una statura non eccelsa, che non lo fece superare i 2 metri.
Per sopperire alla mancanza di centimetri, sin dai primi vagiti cestistici Wallace si dedicò anima e core ai cosiddetti intangibles, mettendo in campo un’intensità ed una voglia che gli sarebbero venute molto comode in futuro. Finita l’high school, tuttavia, di offerte per andare al college non ne erano arrivate. La sua carriera era al primo di numerosi bivi.
“Ehi tu ragazzino, vieni qua”.
Una spinta, poi un’altra, un colpo duro, sangue che scorre. Ben, chiamato tra i vari astanti di un camp estivo a prendere parte a questa partitella 1vs1, aveva assaggiato in prima persona cosa volesse dire marcare un giocatore NBA. Il veterano, tuttavia, rimase dapprima sbalordito e poi compiaciuto dal vedere che quel ragazzo taciturno rispondeva per le rime, rendendo pan per focaccia azione dopo azione. Per Charles Oakley, pretoriano di Jordan prima ed Ewing poi, quella feroce determinazione vista negli occhi di Wallace in quel match non passarono inosservate.
Fu proprio The Oak ad instradare il ragazzo verso l’opportunità di giocare al college. Dapprima al Cuyahoga Community College, dove smazzò 7 stoppate ad incontro, quindi all’alma mater dello stesso Oakley, Virginia Union, ateneo di Division II ma con un livello sicuramente più competitivo. Ben guidò la squadra sino alle Final Four andando in doppia doppia di media, sempre con la sinistra tendenza di rispedire al mittente ogni tentativo di tiro avversario.
Dichiaratosi per il Draft 1996, però, le speranze vennero infrante. Nessuno, infatti, lo degnò di una chiamata, nemmeno al secondo giro. Wallace però non si scoraggiò d’animo, determinato a trovare un meritato posto al sole nel mondo della pallacanestro. La prima fermata fu, un po’ a sorpresa, l’Italia e, nello specifico, Reggio Calabria. Il futuro All-Star fece un provino con la Viola, la stessa che avrebbe proiettato verso il cosmo un certo Manu Ginobili, senza però avere particolari fortune. Arrivò una chiamata dai training camp NBA, segnatamente dai Boston Celtics, allenati in quel periodo da M.L. Carr. Quest’ultimo, forse meglio come sventolatore di asciugamani in epoca-Bird che come coach, dopo aver visionato il ragazzo lo tagliò, ritenendolo inadatto per il ruolo di guardia tiratrice, l’unico che aveva prospettato per Ben. Non aveva tutti i torti, date le lacune centimetriche ed offensive del prospetto da Virginia Union, che ora si ritrovava per l’ennesima volta sul marciapiede della Lega.
Domanda riservata ai grandi cultori della storia NBA ed a quelli un po’ meno giovani: qual’è stato il più grande centro nella Lega sotto i 2 metri? Facile la risposta, data l’assenza di molti concorrenti: Wes Unseld. Più largo che lungo, più facile da saltare che da aggirare, Wes era stata una delle colonne dei Bullets campioni del mondo nel 1978, rimanendo poi a Washington nel front office. Prototipo dell’uomo squadra, aveva intravisto qualcosa in quel ragazzo dell’Alabama, delle doti sicuramente nascoste ma che sarebbero prima o poi esplose. Fu così che, poco prima dell’inizio della regular season, firmò Wallace, facendogli di fatto iniziare l’avventura nel basket professionistico.
L’impatto di Ben con Washington fu abbastanza trascurabile. Pochi i minuti concessi nei primi due anni, tanta panca e “lezioni in privato”, nonostante già qualche segnale delle doti del giocatore (1,1 stoppate in appena 16 minuti nell’anno da sophomore). Nella stagione del lockout, complice anche la trade che mandò a Sacramento Chris Webber, Wallace riuscì a ritagliarsi un minimo di spazio e diverse apparizioni in quintetto. In una squadra non proprio trascendentale, ed in appena 27 minuti di utilizzo, fece registrare 8,3 rimbalzi e 2 stoppate di media, numeri molto interessanti ed indicativi di una certa qual presenza sotto le proprie plance. Nella Capitale, tuttavia, non ci credettero abbastanza. In estate, infatti, venne inserito nella trade-Austin e spedito agli Orlando Magic.
In Florida Ben trovò un giovane coach, Doc Rivers, che gli dimostrò fiducia sin dalla prima palla a due, mandandolo in quintetto in tutte le partite della stagione tranne una, seppur con un minutaggio identico all’ultima stagione ai Wizards. Schierato da ala forte, mantenne gli stessi numeri dell’annata precedente, dimostrandosi un non-fattore in attacco, un pessimo tiratore di liberi ma importante per gli equilibri difensivi di una squadra che, partita a fari spenti, giocò una stagione entusiasmante, sfiorando i Playoffs.
Con un gruppo giovane ed una dirigenza ambiziosa, i Magic cullarono a lungo il sogno Tim Duncan via free agency, vedendoselo sfumare proprio in dirittura d’arrivo. Ripiegarono così su un duo che, nelle intenzioni, doveva ricalcare quanto fatto da Jordan e Pippen: Grant Hill e Tracy McGrady. E Ben? Presto detto: nell’affare per l’ex stella di Duke venne inserito anche Wallace, che così, nell’estate del 2000, iniziò la propria avventura ai Detroit Pistons. Già due squadre non avevano creduto in lui e presto se ne sarebbero pentite.
13,2 rimbalzi e 2,3 stoppate: questo l’impressionante bottino tenuto dal ragazzo dell’Alabama nella sua prima stagione in Michigan. Da quasi carneade a demone furibondo sotto i propri tabelloni, divenne immediatamente un idolo per i tifosi, che in lui rivedevano una versione decisamente più edulcorata di un certo Dennis Rodman.
La nomina di Rick Carlisle come head coach nell’estate del 2001 trasformò la franchigia. Partiti senza grandi prospettive, i Pistons finirono addirittura col vincere la propria Division, sospinti da un Wallace capace di vincere il titolo di Difensore dell’anno, dopo aver vinto contemporaneamente la classifica dei rimbalzi (13) e delle stoppate (3,5). No, non era più uno sconosciuto, anzi era ormai in grado di cambiare le sorti difensive di una squadra da Playoffs. Ad ogni suo pallone toccato, lo speaker faceva partire il rintocco di una campana, come imponeva il suo nuovo soprannome, Big Ben.
Nell’annata seguente i Pistons migliorarono ulteriormente, raggiungendo le Finali di Conference per la prima volta dai tempi dei Bad Boys. Wallace rivinse il DPOY e il titolo di miglior rimbalzista, con un’astronomica media di 15,4 carambole a gara, senza tralasciare il primo dei quattro All-Star Game che avrebbe disputato, una vera e propria rarità per un undrafted.
Dopo la sconfitta alle ECF contro New Jersey, Joe Dumars, l’architetto della squadra, predispose un cambio della guida tecnica. Al posto di Carlisle sarebbe arrivato, per la stagione 2003-04, il girovago per eccellenza, Larry Brown. Detroit aveva costruito una squadra molto rispettabile: Ben a parte, le guardie erano Chauncey Billups e Rip Hamilton, da ala piccola ecco il giovane Tayshaun Prince a difendere come un ossesso sul perimetro. A completare il mosaico, arrivò a febbraio, proprio alla deadline, l’uomo designato ad occupare lo spot di ala grande, dando un pizzico di imprevedibilità in più all’attacco di Brown.
Con l’arrivo di Rasheed Wallace Detroit si trasformò, diventando una vera e propria contender. Con i rimbalzi di Ben a farla da padrone, la squadra si liberò di Milwaukee, Nets e Indiana nei Playoffs ad Est, giungendo sino alle NBA Finals 2004 contro i temibili Los Angeles Lakers di Shaq, Kobe, Payton e Malone. In una serie dal pronostico a senso unico, il “play the right way” riuscì a sovvertire ogni previsione della vigilia. Big Ben, ottimamente coadiuvato dai compagni, contenne alla stragrande O’Neal, chiudendo la serie addirittura in doppia doppia di media, con 10+14 e 2 stoppate. Cosa ben più importante, però, fu che i Pistons si sbarazzarono in appena 5 gare di LA, vincendo così uno dei più improbabili titoli NBA di sempre. Per il prodotto di Virginia Union era il coronamento di una grande rincorsa, che solo tramite sudore, dedizione e tanto lavoro aveva ottenuto, come premio, il trofeo più ambito per un giocatore di pallacanestro.
Nei due anni seguenti Wallace vinse il terzo e quarto titolo di Difensore dell’Anno, eguagliando Dikembe Mutombo al vertice dei pluripremiati nell’apposito albo d’oro. I rimbalzi arrivavano sempre come se piovesse, quasi quanto l’enorme spirito di sacrificio e leadership trasmesse ai compagni sul parquet. Nel 2004-05 Detroit si arrese solo in gara-7 delle Finali NBA ai San Antonio Spurs, dando vita ad un accesissimo duello sul parquet. Nella stagione seguente, con Flip Saunders al timone, i Pistons vennero sconfitti alle Finali di Conference dai Miami Heat, dopo una grandiosa regular season, contro quell’O’Neal
di cui è stato uno dei più fieri eversori. Nonostante le cifre rimanessero ottime, Ben mostrava qualche primo segnale di calo, vuoi per l’età non più freschissima, vuoi per lo stile peculiare. I problemi più grossi, però, erano fuori dal campo. Beghe contrattuali sul rinnovo col front office lo portarono ad un clamoroso divorzio da Detroit. La nuova squadra di Wallace sarebbero stati i Chicago Bulls.
Chicago era una franchigia giovane, dalle ottime prospettive future, che tramite il Draft ed un (lungo) periodo di ricostruzione era riuscita a tornare nei Playoffs dopo una dolente astinenza. Ben era stato individuato come quell’uomo in più che avrebbe ancorato il pitturato dei Bulls, riportandoli ai fasti di un tempo, sotto l’egida di un’impronta difensiva voluta da coach Skiles. I numeri furono discreti, solita doppia cifra di rimbalzi e stoppate in aiuto, ma le cose non funzionarono per il verso giusto. Forse Wallace si aspettava ulteriori considerazioni nella metàcampo offensiva, forse il declino era sempre più accentuato; di sicuro non mancarono le frizioni col ruvido Skiles che, ad esempio, impose il suo veto sull’uso delle fascette tergisudore in fronte, creando un vero e proprio incidente diplomatico col suo centro.
La parabola discendente si accentuò. Dopo neanche un anno e mezzo venne scaricato da Chicago ed inserito in una trade che lo portò ai Cleveland Cavaliers, al cospetto di LeBron James. In Ohio subì un grave infortunio alla tibia, che ne peggiorò ulteriormente le cifre e l’impatto. Ad ogni modo, da ottimo professionista, diede sempre il suo contributo, in allenamento ed in gara, facendo parte di un gruppo che sfiorò le Finali nel 2009, annientato da un Dwight Howard contro il quale sarebbe servito il vero Wallace, quello che difendeva come un ossesso su tutti i lunghi avversari.
Un anno e mezzo dopo, nell’estate 2009, Ben venne spedito ai Phoenix Suns nell’affare-O’Neal. Subito tagliato dalla franchigia dell’Arizona, in una sorta di giorno della marmotta, si ritrovò come ad inizio carriera, senza squadra. La situazione, anche questa volta però, durò poco. A riaccogliere tra le proprie braccia il più amato dei figliol prodighi, i Detroit Pistons rifirmarono Wallace per il secondo ed ultimo stint con la maglia più amata.
Per tre anni, non certo pieni di vittorie e riconoscimenti, Ben ha difeso nuovamente il canestro della squadra del Michigan, sfiorando anche numeri interessanti, se parametrati ad età e minutaggio. Con la fine della stagione 2011-12 si è conclusa, a 37 anni, l’esperienza di Ben Wallace in quella NBA che aveva sempre sognato sin da bambino; non prima però di aver battuto il record, precedentemente stabilito da Avery Johnson, per il maggior numero di partite disputate (1088) nella Lega da un undrafted.
Trentesimo rimbalzista ogni epoca, dopo aver scollinato a quota 10 mila, e tredicesimo stoppatore NBA con oltre 2100 tiri respinti al mittente. Non male per un taglio di Reggio Calabria o per una shooting guard (con shooting nullo) bocciata dai Celtics. Ma un esempio massimo di giocatore che tutti vorrebbero avere nella propria squadra, fonte d’ispirazione per tutti quei giovani che, pur non avendo particolari doti innati, sognano di conquistare il palcoscenico più ambito con sudore ed etica lavorativa. Proprio come Big Ben, il baluardo del canestro dei Pistons Campioni NBA.
“…from Vi-rgi-nia U-ni-on U-ni-ver-si-ty. BBBBBBB Ben, Wuuuuuuallace!”
Alessandro Scuto