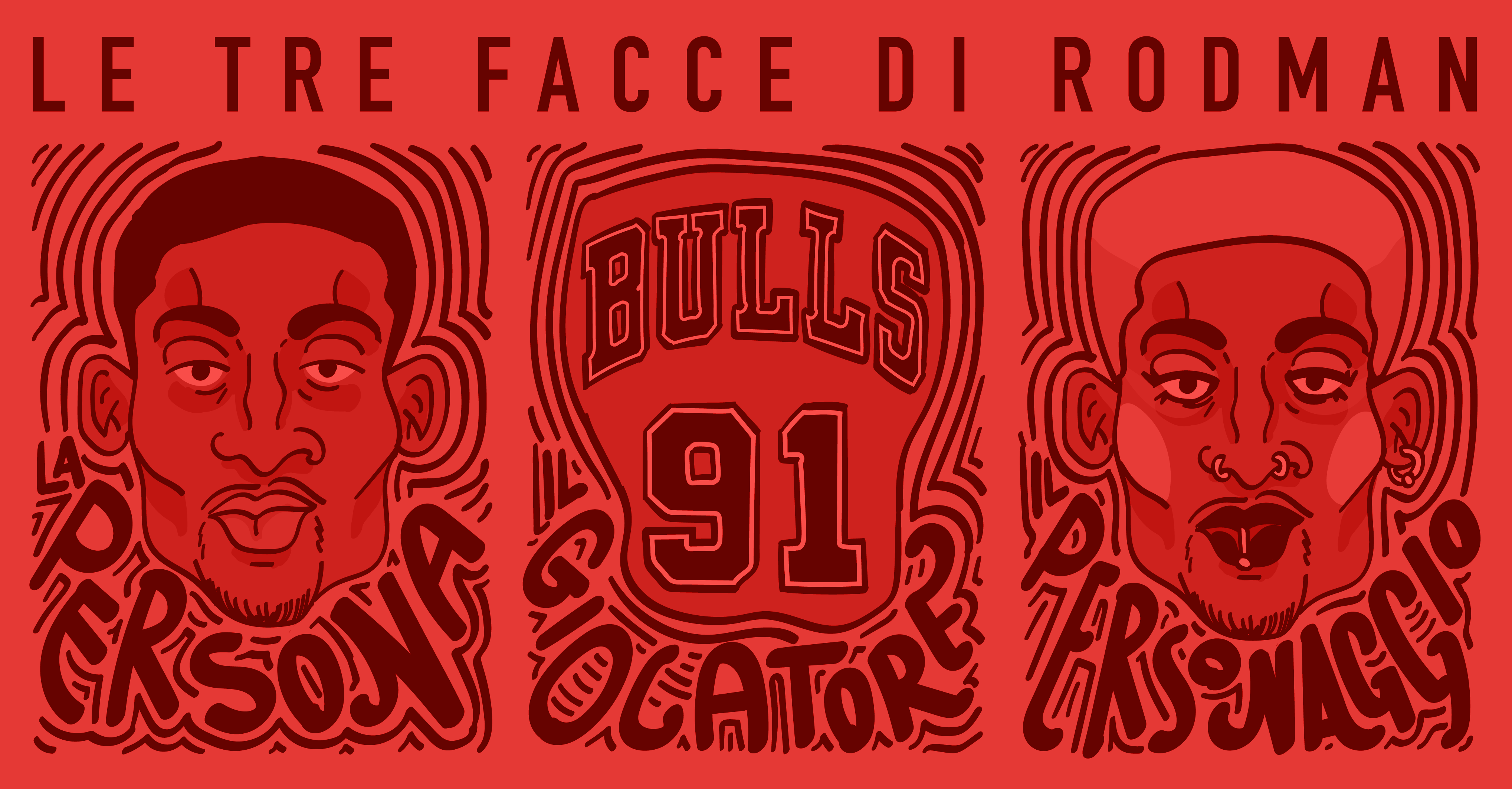Accaldati dalle temperature estive, facendo mentalmente i conti per l’arrivo delle ferie o, per converso, sotto un ombrellone pensando alla fine delle stesse, non c’è niente di meglio di osservare la free agency NBA per svagare con la mente. Firme inaspettate, GM che si distinguono sia in positivo che in negativo, le squadre che si rinforzano sulla carta o contratti che, da lì a breve, diventeranno dei veri e propri albatross.
Quest’anno, a rendere ancora più caotica, incredibile e divertente tutta la vicenda, ci ha pensato un episodio ormai salito sul proscenio, candidato di diritto ad essere ricordato a lungo come una dei più grandi backdoor in sede di free agency. Come ben noto, DeAndre Jordan, il centro dei Los Angeles Clippers, ha dapprima accettato verbalmente (come si può fare tra l’1 e l’8 Luglio) il contratto propostogli dai Dallas Mavericks, salvo poi pentirsene, alla Padre Maronno, proprio sul più bello, decidendo di ritornare nella Città degli Angeli, con i tifosi Texani che si sono sentiti come il mitico Dorando Pietri in vista del traguardo a Londra 1908.
Guardando indietro nel tempo nella storia della Lega, abbiamo trovato altri casi, più o meno similari, che non faranno certamente sentir meglio i sostenitori dei Mavs, ma che ci fanno capire come “un business è un business” e che Jordan non sia l’unico ad aver effettuato il clamoroso dietrofront.
Uno dei casi più eclatanti, nemmeno troppo distanti da noi per quanto riguarda gli anni passati, avvenne nell’estate del 2004. I Cleveland Cavaliers, per l’ennesima volta, avevano mancato l’accesso alla postseason, ma in quell’occasione col sorriso stampato, grazie alle prestazioni di un rookie meraviglia di nome LeBron James. La franchigia dell’Ohio aveva costruito un nucleo giovane e dalle buone, se non ottime, prospettive, Tra i ragazzi terribili ve ne era uno che veniva dall’Alaska ed aveva avuto una crescita vertiginosa, tanto che lo stesso LBJ lo aveva definito “la power forward che vorrei fino al giorno del mio ritiro”. Uscito da Duke, Carlos Boozer era stato scelto solo al secondo giro del Draft 2002, ma aveva subito fatto intravedere buone cose. Con l’arrivo del fenomeno da Akron, anche i numeri dell’ala forte crebbero, toccando i 15 punti ed 11 rimbalzi di media, sfornando doppie doppie come se fosse un novello Duncan. Cleveland aveva una team option sul giocatore, che le avrebbe consentito di tenere Boozer a cifre davvero irrisorie, sui 600 mila dollari circa. Per non voler poi perderlo in futuro, e ricompensarlo per la grande annata disputata, il proprietario della franchigia, Gordon Gund, per ironia della sorte semi-cieco, raggiunse un accordo verbale con Carlos e relativo agente, Rob Pelinka, per fare uscire Boozer dal vecchio contratto, renderlo un free agent con restrizione e rifirmarlo a 41 milioni per 6 anni. Nessuno poteva immaginarsi cosa stava invece per succedere. Contemporaneamente, infatti, il prodotto di Duke, raggiunse un accordo con gli Utah Jazz, sempre per 6 anni ma a 68 milioni di dollari. I Cavs potevano ancora pareggiare la cifra, ma Gund si sentì tradito alle spalle dal giocatore, lasciandolo quindi andare nello Stato dei Mormoni; successivamente, scrisse una lettera a cuore aperto ai tifosi della squadra, dimostrando come la sua fiducia fosse stata accantonata e, da lì a breve, abbandonò il timone della società, passando il testimone a Dan Gilbert. Boozer cercò di spiegare che il suo voltagabbana era dovuto alla scarsa considerazione che aveva di lui lo staff tecnico di Cleveland, a partire da Coach Silas, ma le sue parole peggiorarono, se possibile, la situazione. Lo stesso Rob Pelinka decise di non essere più il suo procuratore, per tenersi alla larga dalle polemiche e mantenere le distanze dal proprio assistito. Da quel giorno Boozer divenne il nemico pubblico numero 1 della Quicken Loans Arena.
Caso vuole che anche il secondo protagonista del nostro articolo sia un ex-Duke e di professione power forward, chiamato a risollevare una franchigia notoriamente sfigata, ma fuggito via sgattaiolando dalla porta sul retro. Elton Brand era arrivato a Los Angeles, sponda Clippers, nel 2001, contribuendo con il suo gioco interno e la sua professionalità a far crescere i cugini poveri californiani, sfiorando un incredibile Finale di Conference nel 2006, persa solo in gara-7 a Phoenix e con un Elton da MVP per tutto l’anno. Nell’estate del 2008 Brand, reduce da un’insidiosa operazione al tendine di Achille che gli fece disputare solo 8 partite quell’annata, uscì dal contratto con Los Angeles, promettendo in questo modo di consentire al suo management di firmare un altro top player, strumentale alla causa. L’identikit di quest’ultimo corrispondeva a Baron Davis, in rotta con Golden State, che proprio parlando con Brand si convinse a firmare con i Clippers per formare un devastante 1-2 nella Western Conference. Tutto fatto? Nemmeno per idea. Fu a quel punto, infatti, che entrò in scena uno dei personaggi più potenti, forse, della storia NBA, David Falk. Già rappresentante, tra gli altri, di un certo Michael Jordan, Falk, da agente di Elton, si intestardì in una lotta senza quartiere col front office di Sterling&Company. A suo dire, infatti, i dirigenti di LA avevano dato un ultimatum alla propria stella per firmare un contratto da 70 milioni, un atteggiamento sgradito all’entourage di Brand, indispettito per un comportamento non ritenuto corretto verso il giocatore franchigia. Nonostante i presunti rialzi successivi dei Clippers, arrivati sino a quota 81, Falk e Brand decisero di lasciare, a dispetto dei buoni propositi iniziali, la California, emigrando verso i Philadelphia 76ers per 82 milioni complessivi, 12 in più della proposta di partenza di Sterling, ma quindi solo uno in più rispetto all’offerta finale di Dunleavy Sr., comunque mai confermata ufficialmente. Le vere “vittime” di questo scontro da Mezzogiorno di Fuoco furono i giocatori, piuttosto che le franchigie: Brand, tra infortuni vari, non riuscì più a replicare quanto fatto di buono in California, mentre Davis, che firmò lo stesso coi Clippers nonostante il dietrofront di Elton, entrò in un’accentuata parabola discendente.
Qualche altra similitudine col caso DeAndre Jordan, soprattutto per certi risvolti da telefilm comici neanche di primo livello, la ebbe la vicenda di Antonio McDyess. ‘Dice, una vera e propria forza della natura, con la dinamite nelle gambe, si mise subito in mostra con la squadra con la quale iniziò la propria carriera NBA, i Denver Nuggets. Dopo due anni buoni, in una complessa trade, venne spedito ai Phoenix Suns, in un roster di primo livello con gente come Jason Kidd, Rex Chapman, Clifford Robinson, un declinante Kevin Johnson ed un acerbo Steve Nash. In Arizona McDyess compì un ulteriore salto di livello, togliendosi pure lo sfizio di partecipare ai Playoffs e di far registrare numeri importanti contro gli Spurs del rookie Duncan. Al termine di quell’annata, però, il giocatore era free agent, con un futuro incerto anche a causa del lockout del 1998. Una volta riprese le operazioni cestistiche, nel Gennaio del 1999, un indeciso McDyess si trovò di fronte ad una scelta impegnativa, ossia ritornare ai Denver Nuggets. La sera in cui doveva firmare, al Pepsi Center, il contratto che sanciva il re-inizio dell’avventura in Colorado, il prodotto di Alabama ebbe un secondo ripensamento, telefonando ai compagni di Phoenix ed esprimendo le proprie perplessità. Kidd, veloce dentro e fuori dal parquet, organizzò in fretta e furia una spedizione, composta da lui, George McCloud e Rex Chapman, che si catapultò all’aeroporto per, tramite jet privato, raggiungere McDyess a Denver per fargli cambiare idea. Il coach e GM dei Nuggets di allora, Dan Issel, fiutò il pericolo incombente nell’aria. Il giocatore doveva firmare il contratto in una suite dell’arena, durante la partita di hockey dei locali Avalanches. Intuendo la volubilità del ragazzo, soprattutto davanti a certi squali in arrivo dall’Arizona, istruì gli addetti del palazzetto a non far entrare il trio proveniente da Phoenix. Kidd e soci si fiondarono verso l’arena, ma gli zelanti inservienti impedirono loro l’accesso, lasciandoli fuori in macchina mentre imperversava una violenta tempesta di neve. McDyess allora, vedendo che il tempo continuava a trascorrere, decise di non aspettare più, di tener fede alla prima parola e di tornare alla corte dei Nuggets. Se ne sarebbe pentito poco dopo: nonostante un’ulteriore esplosione in termini di impatto e cifre, con a corollario la convocazione per le Olimpiadi del 2000, i risultati di squadra furono inesistenti. Le ginocchia, purtroppo, cedettero pure sul più bello, facendo svanire un atletismo a tratti incontenibile e trasformando il giocatore, che sarebbe poi diventato ottimo role player, prima a Detroit (soprattutto) e poi a San Antonio.
Di altri casi simil-De Andre Jordan ce ne sono dunque stati negli anni passati, anche magari meno eclatanti di quelli segnalati. Certo, ai tempi non era possibile fare la “guerra di emoji” o postare su Twitter foto di barricate in casa stile Parigi il 14 Luglio. Oppure, sempre sui social network, assistere, sgranocchiando pop-corn, a diatribe tra giornalisti ed il vulcanico Mark Cuban, la cui presenza a casa Jordan la notte del Grande Ripensamento sta assumendo i contorni della leggenda, quasi quanto l’immortale uscita di DeAndre sulla sua non risposta alle chiamate dei Mavs (“Ero ad un appuntamento galante”). Mettetevi comodi, prima ancora delle prossime infuocate sfide tra queste due squadre nella prossima regular season, usciranno altri strepitosi retroscena di questa grottesca vicenda. Fino al prossimo backdoor contrattuale, magari già dalla prossima offseason.
Alessandro Scuto