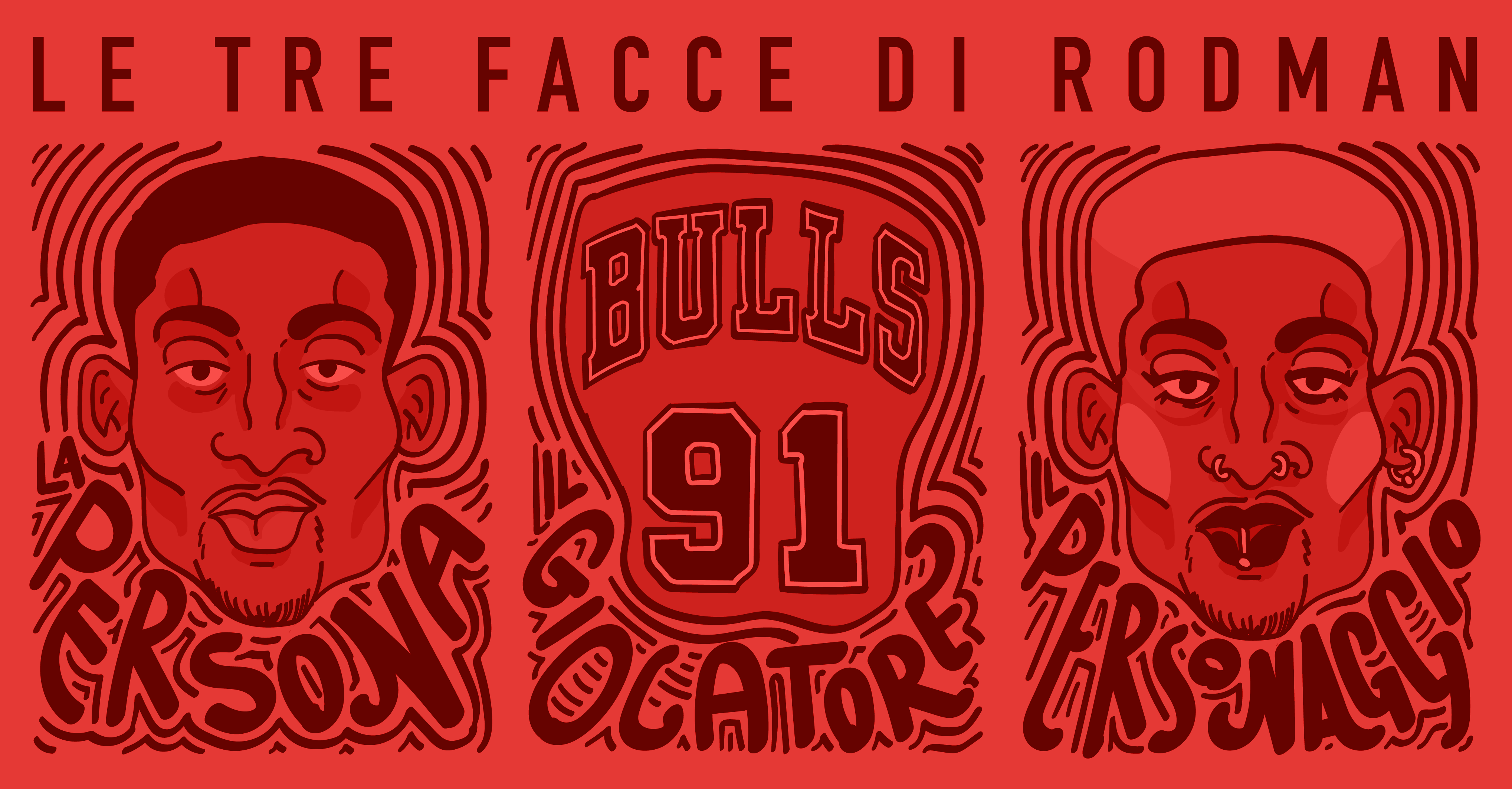“My story isn’t done”.
Derrick Rose entra in sala stampa con gli occhi fissi sulle stampelle che lo accompagnano mentre infila un passo dopo l’altro, appena 13 giorni dopo la seconda operazione alle ginocchia in 19 mesi, si siede e alza lo sguardo. Regala ai giornalisti la solita espressione malinconica, irrigidita dalla frustrazione per aver salutato, dopo appena dieci partite, la seconda stagione consecutiva. Nonostante il suo tono pacato, scandisce le parole con rabbia. C’è chi prova a chiedergli cosa dovrebbero fare i Bulls senza di lui. C’è chi millanta sul suo futuro, chi si scopre dottore e tramite i social network lancia referti medici. DRose zittisce le voci e afferma, secco: “I know I’m going to be all right”. La conferenza stampa dura 22 minuti in cui Rose ribadisce sempre lo stesso concetto: non sono finito. “My story isn’t done”, appunto. Poi le luci si spengono, il Berto Center si svuota e all’MVP 2011 non resta che tornare a lavorare. Pesi, allunghi, piscina, tutto come l’anno precedente, quando l’operazione fu ben più drastica: perforazione della tibia e del perone per sostituire il legamento lacerato con un pezzo di tendine rotuleo. La sfortuna, o chi per lei, sembra essersi accanita sul talento di Chicago. Il destino sembra non volersi compiere. Sì perché non molti sanno che prima di DRose, nella Città del Vento brillava un’altra stella -eh no, non sto parlando di MJ-. Un altro talento che come Rose è cresciuto nei quartieri poveri di Chicago e, in una città dedita al football, ha scaldato i cuori di migliaia di appassionati.
Perché mentre i Pink Floyd nel marzo del 1967 lanciavano il loro primo singolo Arnold Layne/Candy and a Currant Bune, dall’altra parte dell’oceano nasceva Benjamin Wilson, un ragazzo che involontariamente segnerà il percorso sportivo dell’MVP 2011. Benji nasce nella zona sud di Chicago e la sua passione per la palla a spicchi è subito evidente. Il feeling con l’arancia va migliorandosi grazie alle ore passate al campetto a provare finte, movimenti, tiri a canestro che contribuiranno a renderlo uno dei prospetti più appetibili per le high school locali e, al principio degli anni ottanta, serviranno a classificarlo come primo nella speciale graduatoria dei migliori liceali d’America. E’ il giusto tributo a un giocatore che, grazie alla sua capacità di volare sopra al ferro, galvanizza i propri tifosi e sembra lanciato verso la pallacanestro che conta. Ne è passata infatti di strada da quando giocava assieme ai suoi fratelli nel campetto a Cole Park quando, nel 1984, veste già la maglia giallo blu numero #25 dei Wolverines del liceo Simeon Vacation, che condurrà al primo titolo statale, vinto da MVP contro l’allora imbattibile Evenston High School. Ormai il profilo di Benji è sulle scrivanie di moltissimi college, due su tutti De Paul e University of Indiana, che sono pronti letteralmente a fare follie pur di reclutare “Best in the Nation”, come iniziano a chiamarlo alle partite. Ma come ci erudiscono ognuno di noi appartiene all’onda del mare della vita e non possiamo sapere, spero perdonerete la vena leopardiana, quando ci toccherà essere subissati da una tempesta improvvisa. Perché nei quartieri della periferia di Chicago basta poco per meritarsi di morire. E così capita che un giorno, mentre Benji sta discutendo con Jetun, la fidanzata storica, inciampi su un uomo, William Moore. E la vita decide di far esplodere la miccia finale: il fato, o chi per lui, impone che Moore si offenda per quello spintone involontario, estragga la pistola e spari a freddo contro Benji. La pallottola colpisce il fegato e lo lacera. Il ragazzo perde molto sangue, viene portato in ospedale. In 8mila si radunano a scuola e pregano per lui. La mattina dopo, il 22 novembre 1984, i medici diramano il bollettino medico: Benjamin Wilson è deceduto. Ai funerali parteciperanno 10mila persone e sulla sua tomba verrà inciso l’unico epitaffio possibile per un giocatore, ma soprattutto un ragazzo, che verrà considerato un esempio da seguire da moltissimi ragazzi in futuro: “Best in the Nation”. E il destino frena. Chicago piange la scomparsa di un ragazzo così giovane e l’incantesimo sembra spezzarsi.
Quasi quattro anni dopo, nell’ottobre del ’88, nasce a Chicago quello che è effettivamente il protagonista del nostro racconto. Ma sono sicuro che non avrebbe suscitato nella città di Chicago tutta questa empatia se non fosse stato preceduto da Benji. Perché la Windy City è alla ricerca di un erede che possa continuare il sogno interrotto così bruscamente da un infame colpo di pistola. E questo Derrick, nato nell’umile quartiere di Englewood a Chicago e chiamato Poohdini, dalla crasi di Houdini (per le magie che fa col pallone) e Winnie de Pooh (per la sua passione per i dolci) conosce perfettamente la storia di colui che fu il Migliore della Nazione. E quando, anche lui baciato dal talento della pallacanestro, entra per la prima volta nello stesso palazzetto in cui Benji vinse il titolo nel 1984, non ha dubbi su che numero di maglia scegliere. Decide di prendere in dote il numero del Migliore. Si carica sulle spalle un’eredità pazzesca, con una città che praticamente gioca con lui e lo spinge ad andare sempre più su, a schiacciare gli avversari. Arrivano due titoli statali, così da poter abbinare un paio di gemelli allo stendardo celebrativo dell’annata ’84. Derrick Rose domina sugli avversari e risveglia l’orgoglio di una città che affida ad un ragazzo dagli occhi malinconici e l’aria impassibile un fardello importante qual è quello di vincere. Vincere e basta. Che è poi quello che succede visto che Rose lascia il liceo con uno score complessivo che recita 120 W e solo 12 sconfitte. La scuola ritira il suo numero (e quello di Benji) e Poohudini, come già accennato, parte per Memphis alla conquista del titolo NCAA.
Ad attenderlo c’è coach Calipari che però non può consegnargli la maglia n°25 visto che l’università l’ha ritirata in onore di Penny Hardaway. Così Rose decide di portarsi appresso un pezzo di Chicago e, come tutti i bimbi cresciuti con il cartone animato The G.O.A.T. sceglie di indossare la maglia n°23. Vince la South Region con un record di 33 W e 1 L, al torneo NCAA parte da testa di serie e migliora tutte le proprie statistiche, arrivando a due tiri liberi dal titolo. Ma Rose sbaglia il cesto dalla lunetta e Mario Chalmers, che abbiamo visto in questi anni con la maglia dei Miami Heat, con la tripla e una preghiera manda la partita all’overtime, che vedrà poi vincitori i giocatori di Kansas. Dopo un solo anno di college e la delusione del torneo NCAA, Rose decide che è pronto per il grande salto. Ad Aprile, quando si dichiara eleggibile per il draft NBA, è dato da molti come possibile prima scelta assoluta, in ballottaggio con Michael Beasley. I Chicago Bulls, finiti noni nella Eastern Conference, hanno solo l’1,7% di possibilità di pescare la pick #1, ma la lottery sorride alla città natale di Rose e il destino sembra compiersi. Perché credere alla reincarnazione può far sorridere, in effetti è un’idea tanto affascinante quanto improbabile. Ma a volte nella vita bisogna crearsi una sorta di equa giustizia, c’è il bisogno di credere al lieto fine. E allora si arriva a pensare che Benjamin Wilson riviva attraverso le gesta di Derrick Rose, Poohdini, il ragazzo che amava dolci e tirare a canestro e ora sbarca da superstar nella NBA. E’ dolce, per chi abita i quartieri malfamati di Chicago ed è alla ricerca di nient’altro che un motivo per credere in qualcosa, pensare che tutto sommato che il genio incompiuto di Benjamin Wilson sgorghi e si trasmetta nel corso del tempo unendo due generazioni e due corpi in un unico destino: giocare a pallacanestro.
Drose ai tempi di MemphisE il gioco di Derrick Rose è esaltante: rookie of the year, ma soprattutto 36 punti, 11 rimbalzi e 4 assist alla prima partita assoluta ai playoffs NBA (contro i Boston Celtics, campioni in carica), pareggiando il record di punti all’esordio ai PO per un rookie, appartenente ad un certo Lew Alcindor e diventando il secondo -dopo Chris Paul- a far segnare 35 + 11 all’esordio nei playoffs.
Ma aldilà dei semplici numeri, Derrick Rose incarna lo spirito di una città che da dieci anni, dopo i fasti dell’era Jordan, naviga a vista fra scelte sbagliate ed annate deludenti. Poohdini gioca in un modo particolare, si estranea dalla partita e assume come unico credo quello di arrivare a fare punti. Il suo primo passo, quello con cui fa partire l’affondo per il pitturato, è devastante, i giochi di gambe spezzano a più riprese innumerevoli caviglie, gli attacchi al ferro sono devastanti. Il gioco di DRose è totalmente istintivo, basato sulla sensazione di onnipotenza cestistica di uno dei giocatori che fuori dal campo si è dimostrato essere fra i più umili di sempre. Un paradosso a pensarci razionalmente, ma come altro spiegare l’ascesa al trono di MVP di un ragazzo di ventidue anni?
Perché il 2011 è l’anno in cui Derrick Rose entra in missione.
Quell’annata è stata scandita dal lockout e dagli scossoni della Decision di LBJ, ma a prendersi la scena è questo ragazzo che sterza in spazi microscopici e detta legge nella Eastern Conference, fino al titolo di Most Valuable Player 2011. Il più giovane della storia della NBA. E qui dovrebbe entrare in scena il senso storico di ognuno di noi. Perché molto spesso noi osserviamo i telegiornali, leggiamo i quotidiani ma non afferriamo per davvero la portata degli eventi che stiamo vivendo. Dalla politica alle catastrofe naturali, passando per l’economia e arrivando fino ad argomenti più semplicistici (ma non troppo) come lo sport. Derrick Rose ha riscritto una pagina importante di quest’attività: il più giovane di sempre. L’unico, prima di KD questa stagione, a interrompere l’egemonia Lebron James. Già di per sé questa sarebbe una storia speciale, arricchita dalle lacrime di Rose al momento della consegna del premio, quando dedicò il trofeo alla madre.
Poi però, il baratro. Alla prima partita di playoffs della stagione successiva, frastornata da infortuni fisici, il crack. Nel senso che il ginocchio di Rose si spacca. Manca qualche minuto alla fine del quarto periodo, Chicago è avanti di una manciata di punti e sta controllando senza problemi la partita contro i 76ers. Rose sente l’odore del sangue di una squadra che sta per cedere e tenta l’affondo. Penetra in area, salta per cercare un tiro o un passaggio ma gli sbocchi sono tutti bloccati. DRose cade male e si accascia subito al suolo. Il telecronista urla dalla sua postazione: “Holding on to his knee, Holding on to his knee and down”, e il primo ad accorrere quando si ferma il gioco è Joakim Noah che si china sull’MVP più giovane di sempre cercando di capire quali siano le sue reali condizioni. Rose si tiene il ginocchio sinistro e Chicago si paralizza. Un’altra volta, sul più bello? Ma molti pensano che sia solo un incidente di percorso. Rose non ha ancora 24 anni, la riabilitazione è solo una scomoda pratica, uno con il suo fisico come potrebbe non tornare più forte di prima? Eppure.
Eppure le persone non possono sapere cosa c’è dietro una rehab. Il dolore fisico, lo stress, la depressione che può assalire un uomo. “Eh, ma lo pagano milioni per giocare a basket”. Ma quali potrebbero essere le vostre sensazioni se, tutt’un tratto, non riusciste più a camminare? Se il nervo del tendine, bloccato durante l’operazione, vi provocasse un dolore atroce ad ogni passo? “Ad un certo punto non mangiavo più. E la riabilitazione è stata ancora più dura” ha affermato Rose ad USAToday. Poi è arrivato suo figlio, PJ. Che ha parzialmente risolto le cose. Tanto che Poohdini ha affermato: “Sono quasi pronto”. Ma la stagione finisce, con i suoi Bulls che sono stati eliminati (ancora!) dai Miami Heat alle semifinali di Conference per 4-1. Rose parte per una tournée mondiale con il suo top sponsor, autore del famigerato e martellante spot sul Ritorno, che tocca anche l’Italia. E, arrivato a Milano, afferma: “Se la stagione iniziasse domani, sarei in campo”.
E Chicago ricomincia, lentamente, a pulsare. Soprattutto quando, alla prima partita di preseason, Derrick Rose torna. E dopo aver ricevuto qualche pallone giocabile, parte in contropiede. E schiaccia. Schiaccia e aggredisce il ferro. He’s back. E lo si capisce ancora di più alla prima stagionale, quando si gioca contro i campioni in carica, i Miami Heat. Sì, ancora loro.
DRose inizia male, perde subito un pallone aggredito da Mario Chalmers (ancora lui!) che lo asfissia e così concede i primi due punti facili a Miami. Poi accade. Accade che, in una partita vera, niente più amichevoli, Rose ingrani la terza ed entri in area. Entra in area e sterza, scala una marcia e semina avversari per arrivare ad un comodo layup dopo aver scherzato tutta la difesa. He’s really back. E ancora, alla seconda partita contro i Knicks di quel Carmelo Anthony che potrebbe diventare presto un suo compagno di squadra. Quando, ritornato a casa, allo United Center, sigla la giocata della partita con pochi secondi sul cronometro. Le prime dieci partite scorrono con un record di 6-4 e 15.9 punti di medie. Le statistiche al tiro non sono ancora scintillanti, Rose vuole migliorare il suo tiro da 3 (contro i Pacers registra una prova magistrale dall’arco) ma ancora non ingrana del tutto. Tuttavia fa vedere alcune cose che facevano parte del proprio gioco. C’è, sta semplicemente affinando le armi. Poi Portland, il cambio di tempo, il tentato rientro difensivo su un pallone perso, il menisco che si rompe. E qui la storia si riallaccia al nostro input. “My story isn’t done”. Lo ripete ossessivamente, mentre lavora per tornare. E’ frustrante, tutto il lavoro di un anno buttato via. E le stesse critiche sulla mentalità labile, sul fisico scadente. I paragoni con Brandon Roy (che, just to know, era capace di cose come questa) e le sue ginocchia si sprecano. Ma Rose si rimette a lavorare e giura: “Tornerò ancora. Non so che giocatore sarò, ma tornerò più forte di sempre”. Ma questa volta niente riflettori, niente “The Return”, solo il lavoro in palestra e un unico mantra: “Non sono finito qui”.
Come ci ripete sempre chi ne sa un po’ più di noi, e forse sarà vero, un giorno questo dolore ci sarà utile. Perché parlare di sfortuna sarebbe inutile, così come discutere di ciò che ha dovuto vivere in questi due anni Rose. Ma Chicago aspetta l’MVP come si aspetterebbe un fratello convalescente. Come si aspetta, ancora, irrazionalmente, Benji. Perché il legame è viscerale, eterno. Basti pensare che, durante l’annuncio delle formazioni titolare, lo speaker dello United Center quando presenta DR1 non urla “From Memphis”, come dovrebbe essere visto il suo passato al college. No, esclama “FROM CHICAGO”, come se non se ne fosse mai andato. Un po’, e qui il cerchio si chiude, come Benjamin Wilson.