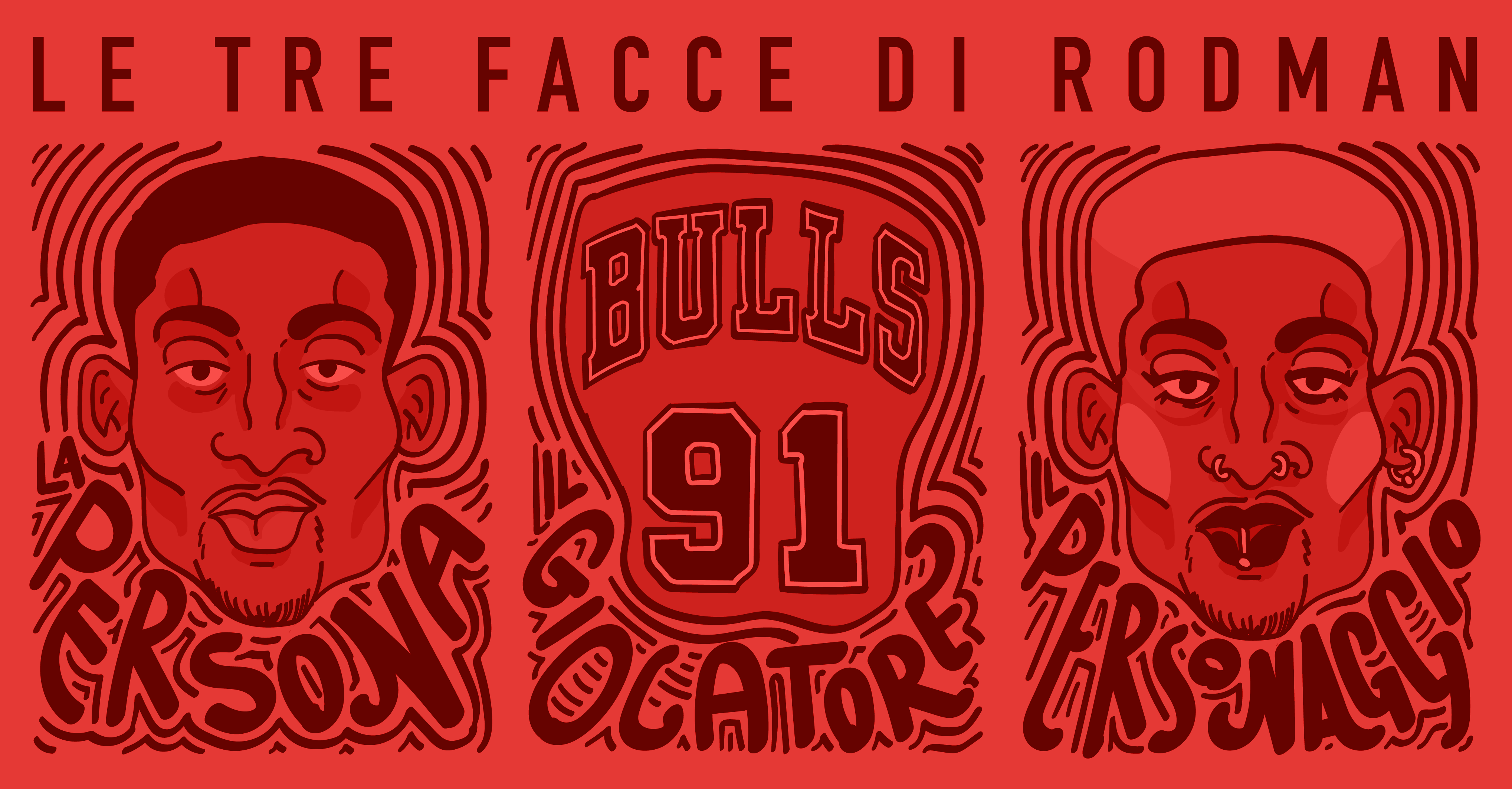L’anno è il 1969, il cognome è Armstrong. Va beh però questa è facile, penserete. E invece no. Mentre quello famoso, Neil, sbarca sull’unico satellite di questo Nostro pianeta, nel mondo del basket a stelle e strisce fa il suo ingresso in scena una fulgida cometa. Il cognome, fino al 1971, è lo stesso di Neil, il nome è Warren.
La cornice è quella dell’Indiana State Fair Coliseum, Indianapolis. E’ in corso gara 3 delle Finals ABA, che vede contrapposta alla squadra di casa (Indiana Pacers) gli Oakland Oaks allenati da coach Alex Hannum, la cui stella, un certo Rick Barry, è costretta in panchina a causa di un infortunio al ginocchio.
Dopo che le prime due gare della serie, giocatesi ad Oakland, si erano chiuse in parità, i Pacers sono sopra di 3 e sul punto di portarsi in vantaggio 2-1 nella serie. A circa 3-4 secondi dalla fine della partita c’è una rimessa per gli Oaks. Bob Leonard, coach dei Pacers, urla ai suoi: “Yellow!”. Significa che devono commettere un fallo intenzionale non appena la palla venga rimessa in gioco, di modo che, andando in lunetta, gli Oaks possano portarsi ad una massima distanza di 1 punto con 2 tiri liberi.
La palla viene rimessa in gioco e arriva nelle mani di Armstrong, che si trova a circa 8-9 metri dal canestro. Tom Thacker, non fa nemmeno a tempo a raggiungerlo per commettere fallo, che la palla è già uscita dalla sua mano e immediatamente si capisce che è uno di quei tiri che sono destinati ad entrare dal momento in cui il tiratore lo riproduce nella sua testa e...CIUF. Nothing but net. Sirena.Overtime.
Da quel momento, come spesso accade, l’inerzia della serie si capovolge arridendo agli Oaks, che, guidati da Armstrong, Doug Moe e Larry Brown (se ve lo state chiedendo: sì quel Larry Brown!) vincono gara 3 di 8 punti in overtime, stravincono gara 4 rifilando agli avversari un distacco di 27 punti e ipotecano serie e titolo in gara 5 sul proprio campo, ancora con un overtime, sconfiggendo una squadra, composta da elementi quali Mel Daniels, Roger Brown e Freddie Lewis, che avrebbe vinto 3 dei successivi 4 campionati.
Il protagonista assoluto però è Armstrong, che in gara 5 segna 39 punti accompagnandoli con 12 rimbalzi e, totalizzando nella serie una media di 33.2 punti e 12 rimbalzi, viene nominato MVP delle Finals. Ah, dimenticavo, all’epoca Warren è un Rookie, fresco di College a Wichita State, e quella stessa stagione si era aggiudicato il premio di “Rookie of the year” facendo registrare 21.5 punti, 9.7 rimbalzi e 3.5 assist di media a partita (numeri à la LeBron James degli ultimi tempi, tanto per intenderci), riuscendo nell’impresa di conquistare, in una sola stagione: Titolo, MVP delle Finals e premio di Miglior Rookie dell’anno. Impresa, che nella storia di questo sport è stata compiuta, circa dieci anni più tardi, solo da un altro giocatore: una guardia di 2,01 metri, che portava un numero 32 su sfondo giallo-viola e aveva sempre un gran sorriso stampato in faccia. Lo chiamavano Magic, vi dice qualcosa?
La straordinarietà di quanto fatto da Warren Armstrong in quella stagione, si coglie benissimo nelle parole di Rick Barry, particolarmente famoso per non essere mai stato un simpaticone né un grande dispensatore di complimenti, ma, in questo caso, probabilmente anche grazie all’infortunio al ginocchio, che gli permise di godersi lo spettacolo dalla panchina, affermò: «Senza dubbio è una delle guardie più forti con cui io abbia mai giocato – assieme o contro – bisogna aspettare che acquisisca solo un po’ più d’esperienza, a quel punto nessuno sarà in grado di fermarlo. Penso che potrebbe diventare uno dei più grandi».
Caro Rick, per una volta, eri arrivato tardi.
Sì perchè Warren grande lo era già, fin dalla più tenera età e non avrebbe potuto essere altrimenti. D’altronde per un afroamericano nascere a Kansas City nel 1946 non doveva essere facile.
Kansas City è sicuramente una delle città più particolari degli Stati Uniti. Talmente particolare che ne esistono due!
Quella in cui Armstrong albeggia è Kansas City nel Missouri, che sorge proprio in prossimità della confluenza del fiume Kansas nello stato del Missouri, il quale la separa dalla sua omonima, ubicata nello stato del Kansas, alla quale è collegata da vari ponti stradali e ferroviari.
La città è sempre stata un catino ribollente di cultura afroamericana. È qui che nasce, infatti, negli anni ’20, lo stile Jazz del Ragtime. Un genere che fa del ritmo martellante la sua caratteristica principale, contrapponendosi dunque, ideologicamente, allo stile dominante, quello di New Orleans, che invece si basa su un’improvvisazione collettiva molto più marcata. Tuttavia il Ragtime non è documentato, dal momento che in città, all’epoca, non esistono case discografiche e neppure grandi orchestre. Il Ragtime viene quindi elaborato ed affinato soprattutto da piccole orchestre itineranti che suonano nella KC Area, le c.d. Territory bands, fino ad essere portato a piena maturazione tra il 1928 e il 1932 dall’orchestra di Bennie Moten, ereditata successivamente da Count Basie, che fa confluire il Ragtime nello Swing. Kansas City ormai è sulla mappa, tanto che qui cominciano a radunarsi famosi solisti, i quali, sfidandosi tra loro in competizioni musicali, completano la loro formazione artistica e affinano la loro tecnica. Fra questi, sicuramente, si possono ricordare il sommo Lester Young e poi lui: The Bird, Charlie Parker, che sublimerà lo Swing inventando il Bebop.
Nonostante ciò, una grossa percentuale della corposa comunità afroamericana di Kansas City vive sotto la soglia di povertà, è disoccupata, non istruita e patisce le angherie della segregazione razziale. In questo contesto Warren e la sua famiglia non costituiscono un’eccezione, tanto che il padre, Warren Armstrong Sr., è costretto a un doppio lavoro per poter mettere assieme il pranzo con la cena.
È chiaro che un giocatore, ma soprattutto un uomo, qual è stato Warren Armstrong, poteva nascere solamente in una città come questa, in un contesto come questo, e tutto ciò: lo spirito di Kansas City, il Ragtime, la povertà, la segregazione razziale, i soprusi, fluiranno in lui e attraverso di lui, influenzando il suo modo di agire sul campo di basket e fuori di esso.
Warren frequenta il liceo presso la Central High School, in un periodo in cui la scena cestistica di KC è particolarmente calda e frizzante. A calcarla sono giocatori quali Jo Jo White (futura stella dei Celtics, che viene da St. Louis per i tornei nazionali) e soprattutto Lucius Allen (che sarebbe poi andato a UCLA, vincendo due titoli NCAA consecutivi, e avrebbe avuto una carriera NBA di alto livello, vincendo anche un titolo nelle file dei Milwaukee Bucks guidati da Lew Alcindor – all’epoca Abdul-Jabbar si chiamava ancora così – e Oscar Robertson), con il quale, sicuramente, Armstrong vive la rivalità più forte della sua gioventù. A dividerli, anzitutto c’è il fatto che Allen proviene dall’altra parte del fiume che separa le due Kansas City, ma non è solo questo. Il loro modo di giocare è agli antipodi. Sono lo Ying e lo Yang della pallacanestro. Due modi diversi di interpretare ed esprimere basket. Allen è una guardia fulminea, finezza pura. Armstrong è forza bruta, dominio e intimidazione fisica. Di tutti questi giocatori, però, lo sanno tutti in città, il più forte è Warren. Il primo a riconoscerlo è lo stesso Allen: «Uno contro uno non avevo una chance contro di lui – dirà -. Mi intimidiva, era un preparato di fisicità.»
«Al college ho giocato contro giocatori come Elvin Hayes e Don Chaney, ma Warren era molto meglio di loro», avrebbe detto di lui Mike Thiessen, first team All-Metro 1965, che aggiunge: «Faceva delle cose al liceo, che oggi vediamo fare a Michael Jordan». E ancora Charles Weems, ex arbitro: «Era un uomo tra i bambini, sapevi cosa stava per fare, ma non potevi fermarlo. Mi sono sempre sentito come se fosse due passi avanti a tutti».
Nondimeno le parole che permettono di cogliere al meglio le caratteristiche salienti del modo di esprimersi sul campo di Warren sono quelle di Jack Bush, coach di Central High School: «Peeler (riferendosi ad Anthony Peeler, altra leggenda del basket Kansasiano, che ha poi militato nell’NBA) aveva gli occhi dietro alla testa. Peeler sapeva passare, ma Warren Armstrong aveva le ali! Non era un gigante, ma la sua verticalità e il suo tempismo erano incredibili. Dominava il gioco con la sua capacità di saltare».
Armstrong gioca guardia, è un 6’2” (circa 188 cm x 91 Kg, un bel torello!) e sa volare. Volare per davvero. È un concentrato purissimo di forza fisica e tecnica. Non solo, ha anche grande senso del campo ed è arcigno nella metà campo difensiva, dove sfrutta la sua imponenza fisica per intimidire i pari ruolo e non andare sotto nemmeno con i lunghi (tanto che parteciperà all’ All-Star Game del 1970, venendo selezionato come Forward). «E’ il 6’2” più grosso che abbia mai visto» dirà di lui Bob Bass, che lo allenerà nei Floridians.
Una giocata che spesso fa consiste nel rubare palla al giocatore avversario nella propria metà campo (se possibile dopo una stoppata), involarsi in un coast-to-coast, palleggiando verso il canestro dalla parte opposta del campo e piantare una sonora schiacciata, baciando il ferro con la fronte. Tutti in piedi.
Domanda che sorge spontanea nella testa di tutti, anche nella mia originariamente: «Sì sì! Forte, forte, ma com’è che se ne sono scordati tutti?» Possiamo dire che la gran colpa è stata delle circostanze, fra le quali anche se stesso.
Nel suo anno da senior alla Central (1964) fa registrare 25.1 punti di media, vince il DiRenna Award, assegnato al migliore giocatore della Lega Interscolastica di KC, e viene nominato nel primo quintetto All-Metro, assieme al rivale Allen. Credenziali per poter ambire ad un College con tradizione. Fortuna che tocca però al solo Allen, che va a rimpolpare le file dei Bruins di UCLA. Per Armstrong, invece, le uniche porte che si aprono sono quelle dei Wichita State Shockers, che avrebbero visto il torneo NCAA col binocolo per almeno altri 15 anni. Warren, però, nei quattro anni di permanenza fra gli Shockers diventa recordman dell’università per assist e rimbalzi, nonché quarto miglior scorer di sempre. Numeri che adesso gli garantirebbero una chiamata fra le prime 5 del Draft, ma è il 1968. A chiamarlo sono i New York Knicks, che lo scelgono con l’8^ pick al 4° giro. 44esimo assoluto. Un affronto. «Grazie, gentilissimi, ma declino». Rifiutata l’offerta dei Knicks, decide di andare in ABA, la lega degli “sfigati”, quelli che giocano col pallone tricolore e non difendono (che poi “sfigati”….fino a prova contraria, negli anni ’70 i più forti son tutti lì, però questa è un’altra storia). Firma per gli Oaks, con tutto quello che poi consegue, e la prima cosa che fa è liberare Armstrong Sr. da uno dei due lavori che aveva svolto fino a quel momento.
Il fatto è che essere stato un afroamericano a Kansas City ha lasciato dentro di lui dei solchi molto più profondi di quelli neri che abbracciano la superficie arancione di uno Spalding.
«Non ho mai considerato lo sport una priorità più elevata, rispetto alla lotta della gente Afroamericana per ottenere il diritto di far parte della Comunità Umana». Parole che starebbero bene nella bocca di Malcolm X o di Jesse Jackson. L’orgoglio per il colore della propria pelle emerge soprattutto quando nel 1971, in un periodo in cui le lotte e i tumulti razziali sono all’ordine del giorno, decide di cambiare il proprio cognome in Jabali, parola swahili che significa “Roccia”. The Rock. Mai cognome fu più azzeccato.
Il carattere, infatti, è di quelli forti, orgogliosi, duri, particolari, eternamente controcorrente, politicamente schierati, avversi ai poteri costituiti, che, in quel periodo storico, sono appannaggio dei Bianchi, l’eterno nemico.
«Non mi avrebbe passato la palla per il solo fatto che sono bianco»; parole e musica di Rick Barry. Carattere che gli avrebbe procurato, com’è facilmente immaginabile, grossi problemi e pessima fama nel corso della carriera. Terry Pluto, addirittura, gli dedicherà un capitolo, dal titolo “The Meanest Men in the ABA”, del suo “Loose Balls”, in condivisione con John Brisker. Uno che, tanto per darvi un’idea, finita la carriera da giocatore professionista se n’era andato in Uganda a fare il braccio destro di Amin Dada. Se a tutto ciò aggiungiamo una serie di infortuni falcidianti, alla schiena e alle ginocchia, che cominciano a perseguitarlo a partire dal 1970, il quadro è completo e il quesito di cui sopra trova immediata risposta.
Le avvisaglie ci sono già al primo anno con gli Oaks, quello dei tre “Tituli”, per dirla alla Mourinho.
Match di regular season contro i Los Angeles Stars. Secondo quarto. Jabali va in penetrazione verso il canestro. Ad attenderlo c’è Jim Jarvis, bianco, che ricorre al solo modo per fermare Jabali in quelle situazioni. Fallo. Nessun fischio. Jabali si volta verso l’arbitro, anch’egli bianco, che in tutta risposta gira la testa dall’altro lato. Da questo momento in poi è giustizia privata. Jabali colpisce Jarvis da dietro, atterrandolo, e, non pago, gli passeggia sulla testa mentre è supino con il naso contro il parquet. «Vedevo cosa succedeva in ABA – dirà anni dopo -.Rick (ndr Barry) faceva 35 punti a partita, però andava in lunetta 10-15 volte su qualunque campo. Io giocavo aggressivo anche più di lui, ma al massimo andavo in lunetta 6-7 volte a partita. Oltretutto Jarvis era uno di quei giocatori, che, non essendo capaci di giocare, avevano sempre bisogno di giocare sporco, così l’ho colpito». Jarvis, in un certo senso, in quel momento rappresentava un esempio paradigmatico di tutte le ingiustizie razziali che Jabali combatteva fin da quando era poco più che un bambino.
Quest’episodio non sarà privo di ripercussioni, soprattutto per il Karma di Jabali.
Nel 1970 infatti, con gli Oaks che nel frattempo si sono spostati a Washington divenendo i Capitols, cominciano a perseguitarlo gli infortuni e, a braccetto con questi, anche i pellegrinaggi per mezza ABA.
Dopo aver fatto registrare un carreer-high di 46 punti, Jabali va sotto i ferri per sistemare un ginocchio. Stagione finita. In estate i Caps lo scambiano con i Kentucky Colonels, con i quali però non gioca nemmeno una partita, visto che, dopo una lite con coach Al Bianchi durante il training camp, i Colonels lo scambiano con i Pacers per una prima scelta e dei soldi.
Qui vive la peggior stagione della sua carriera. Gli infortuni continuano a seguirlo come la nuvola di fantozziana memoria. Son più le partite che perde, che quelle che gioca. Quando gioca però è ancora in grado di accendere la luce, soprattutto verso la fine della stagione. Proprio in virtù di ciò le aspettative per la successiva sono alte, ma si spengono immediatamente. Al training camp del Settembre 1971 il “ragazzo” si presenta con quella decina di chili di troppo, come da abitudine, ma d’altronde cosa ci volete fare? «Il basket non è la mia priorità più alta». Morale: finisce ai Floridians in cambio di scelte non protette e soldi.
Dopo la Florida, dove totalizza circa 20 punti e 6 assist a partita, nel 1972 approda ai Denver Rockets, dove ritrova coach Hannum e Larry Brown, con i quali aveva condiviso momenti di gloria ad Oakland.
Ormai purtroppo le ginocchia e la schiena malconce gli hanno tarpato le ali. Non salta più neanche la Gazzetta. Essendo però un giocatore dotato di un’intelligenza cestistica fuori dal comune, capisce che deve adattarsi. Diventa un giocatore perimetrale, pericolosissimo dall’arco dei tre punti. Ciò nel ’73 gli vale la convocazione all’ All-Star Game, il suo terzo, che si gioca a Salt Lake City.
Nella terra dei mormoni alla voce punti scrive 16 e vince l’MVP, soffiandolo ad illustri signori del gioco come: Julis Erving, George McGinnis e Artis Gilmore. Mica male per un rottame, no?
Anche nella stagione successiva viene selezionato come starter per l’Ovest all’All-Star Game. Quella partita, però, sarà la sua ultima apparizione in rappresentanza dei Rockets. Il giorno dopo il match, infatti, la lega gli dà il foglio di via. Fuori “per aver messo in forte imbarazzo l’ABA”. Pare infatti che prima della partita avesse cercato di convincere i giocatori Afroamericani a boicottare l’All-Star Game in segno di protesta, per solidarietà al movimento per i diritti civili. Azione non riuscita e oltre al danno la beffa: Cacciato!
È il 1974 e, stanco degli Stati Uniti, Warren decide di andare a fare un viaggio. Meta: Tanzania.
Sta lì 9 mesi, fino a quando gli emissari dei San Diego Conquistadors (squadra che meriterebbe una trattazione separata), alla disperata ricerca di una guardia per la stagione 1974-1975, vanno a recuperarlo e gli fanno firmare un contratto. «Va beh, se proprio proprio avete bisogno di me, torno». E torna.
Ha messo su peso e la schiena, ormai, lo costringe a passeggiare per il campo. La visione di gioco, però, sembra non essere capitolata sotto i colpi degli acciacchi e del Dio Crono e grazie ad essa regala ancora momenti di grande pallacanestro.
Uno di questi si concretizza in una notte di Febbraio. In città arrivano i New York Nets di Dr. J., che sono in striscia positiva da 8 partite. I Conquistadors, invece, non vincono da 7.
Il pubblico è quello delle grandi occasioni, la maggior parte però è lì per vedere il Dottore, che non tradisce le aspettative e scrive 45, sfoggiando un abbagliante repertorio di morbidi movimenti e tiri che profumano di bucato.
I Nets prendono il largo e gran parte del pubblico, che si ritiene soddisfatta, comincia ad abbandonare l’arena. La partita sembra in ghiaccio, anche se mancano ancora molti minuti da giocare. A quel punto, probabilmente punti nell’orgoglio, i Q’s tornano in vita. Travis Grant e Dwight “Bo” Lamar cominciano a far piovere dall’arco dei tre punti e Jabali inizia a portare la palla al ferro. Quando restano poco più di 30 secondi alla fine i Q’s sono sotto di 5.
A quel punto Jabali si lancia in una penetrazione, sposta la palla nella mano sinistra e prende l’ascensore. Nel silenzio colmo di stupore di quelli che sono rimasti dentro l’arena, si sentono solo due rumori: quello della palla che sbatte sul parquet, dopo che Jabali l’ha schiacciata con violenza dentro al ferro, e il fischietto dell’arbitro. Questa volta il fallo c’è e viene sanzionato. Jarvis dove sei ora?
Dalla lunetta Jabali trasforma il libero supplementare e porta i suoi a -2. Un tiro di Grant in sospensione dall’angolo completa la rimonta. Pari. Si va all’overtime, come tutto è cominciato.
Nell’overtime, però, il Dottore non sembra intenzionato a fermarsi e ne mette altri 12, arrotondando a 57, ma i Q’s restano a contatto e con un altro buzzer-beater riescono a prolungare la gara. Secondo overtime.
Con due minuti ancora da giocare del secondo tempo supplementare Dr J. ha 61 punti “and counting”, come dicono oltreoceano.
A quel punto però Jabali è in trance agonistica. «Warren, te la senti di marcare Doc?». «No big deal!».
Il secondo overtime si chiude in parità, così come il terzo. Finalmente, nel quarto tempo supplementare, i Conquistadors riescono a portarsi in vantaggio e vincono! Punteggio finale: Conquistadors 176- Nets 166! A quel tempo il punteggio più alto mai registrato nella storia del basket professionistico.
Dr. J. finisce la partita con 63 punti (carreer-high), ma, e sì c’è un ma, negli ultimi 12 minuti di gara, con Jabali in marcatura su di lui, riesce solamente a segnare 2 punti con una schiacciata in garbage time.
Warren invece alla fine della partita sul referto dei punti scrive 23, dei quali 19 tra la fine del tempo regolamentare e i 4 overtimes.
L’orologio sembra essere tornato indietro di 5-6 anni, ma il suo sguardo, al termine della gara, è diverso. Non è più lo sguardo di un ragazzo incazzato col mondo, è lo sguardo di un uomo che ha raggiunto la serenità.
Sarà una delle sue ultime partite da professionista, alla fine della stagione infatti, a soli 28 anni, si ritira e appende le Chuck Taylor al chiodo.
Dopo aver abbandonato il professionismo, si trasferisce con la moglie a Miami, dove finalmente può dedicarsi al suo unico vero interesse: aiutare la sua comunità. In particolare concentra i suoi sforzi sui giovani, cercando di tenerli lontani dalle strade e da tutto quello che è annesso a quel mondo: la droga, l’alcool, la criminalità.
Diventa insegnante di educazione fisica al North County K-8 Center, rimanendo nell’anonimato e lontano dai riflettori. I “suoi” ragazzi lo conoscono solo come Coach Jabali e nessuno ha un’idea di che grande giocatore sia stato.
A quelli più sfortunati, che magari hanno perso uno o entrambi i genitori, paga la quota d’iscrizione affinchè possano giocare a baseball, a football o a basket e poi, durante le partite, si siede sugli spalti per vederli giocare. «Non voglio che guardino in alto sugli spalti e non vedano nessuno lì per loro» dice. Altro che Meanest player o Thug. Andatelo a raccontare a Terry Pluto!
Questa è la sua vita, fino a che, qualche mese fa (Venerdì 13 Luglio), il suo cuore, malato da tempo, smette di battere nel sonno e Warren Jabali lascia questa terra a soli 65 anni.
«Ha lottato, come sempre – dice sua moglie Mary -. Dopo l’operazione a cuore aperto che ha avuto a Febbraio, ho cercato di convincerlo a smettere, ma sentiva che il suo lavoro non era ancora finito, che doveva dare ancora qualcosa».
Sì, forse qualcosa doveva ancora dare, come quella notte del ’75 contro i Nets. La notte in cui “fermò” il Dottore.
Probabilmente se fosse andato in un college prestigioso, se avesse scelto l’NBA, anziché l’ABA, se non avesse avuto infortuni, se non fosse stato una testa calda, se avesse davvero voluto giocare a basket, saremmo qui a raccontare un’altra storia. Probabilmente sarebbe divenuto uno dei più grandi, ma di certo non sarebbe stato Warren Jabali. THE ROCK.
Simone Errante