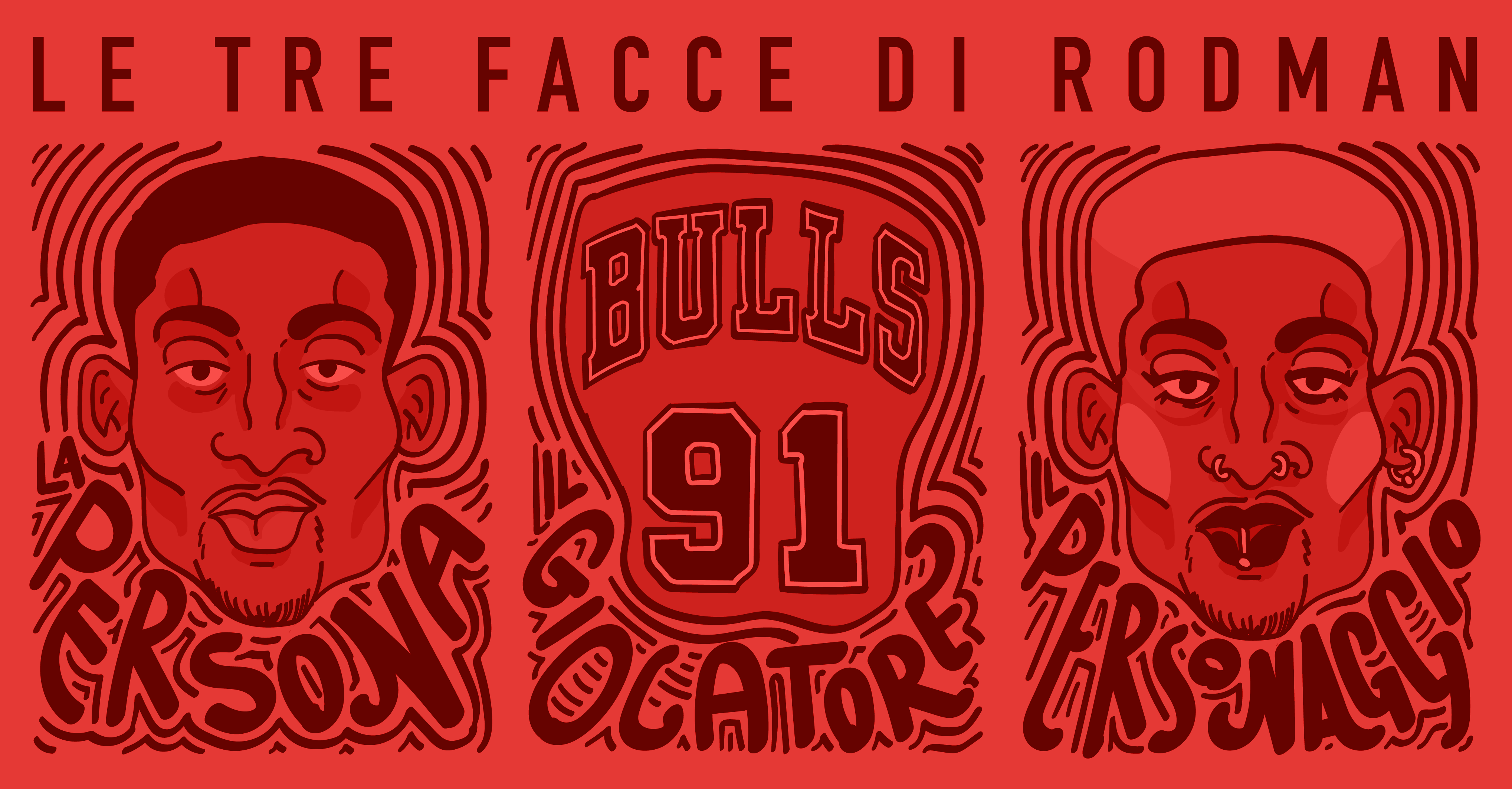Dopo che a fine anni ’60 si esaurì la grande dinastia dei Celtics di Bill Russell e Red Auerbach una sorta di maledizione calò sull’intera Lega: chi vinceva il titolo finiva inesorabilmente per non ripetersi, anche con i favori del pronostico tutti dalla propria parte. Molti neocampioni dichiararono spavaldi che avrebbero infranto il sortilegio la stagione successiva, ma il primo a riuscire a tener fede alla propria promessa fu Pat Riley, che portò i Lakers di Magic e dello Showtime al secondo anello consecutivo nel 1988, a quasi vent’anni dall’ultimo repeat degli acerrimi rivali biancoverdi.
Nell’estate 2010, quando Lebron James esplicitò la sua decisione di, per usare le sue parole, “portare il proprio talento a South Beach”, sembrava scontato che sarebbe stato proprio il timoniere dello Showtime a tornare in pista per mantenere la celeberrima promessa fatta dallo stesso Lebron, quel “not one, not two, not three…” che tante antipatie ha finito per procurargli. Riley, entrato nel frattempo ormai da qualche anno nella dirigenza degli Heat, era già tornato sul pino per portare la squadra al primo storico titolo NBA della franchigia nel 2006, e per molti avrebbe usato lo stesso metodo utilizzato in quell’occasione: dopo l’arrivo di Shaquille O’Neal, aveva fatto iniziare la stagione al coach già sotto contratto per poi prenderne il posto alla prima difficoltà. Se in questo modo aveva dato il benservito a un buon allenatore come Stan Van Gundy (successivamente finalista con i Magic), pareva impossibile che non si ripetesse con quel coach quarantenne che da due anni guidava gli ormai mediocri Heat. Erik Spoelstra, giovane rampante di etnia e influenze culturali variegate, ma dotato di una buona dose di arrivismo tipicamente americano, per quanto mostrasse qualche buona attitudine (nei primi due anni aveva un minimo risollevato una squadra finita nei bassifondi della Lega, riportandola subito ai playoff) e godesse della stima del presidente sembrava veramente l’ultima persona in grado di gestire uno spogliatoio infarcito di prime donne come quello dei Big Three dei nuovi Miami Heat.
E invece, dopo una buona prima stagione, terminata però con il disastro della Finale coi Mavericks, la scelta di Spoelstra ha dato i suoi frutti, portando due titoli consecutivi alla franchigia, proprio come il suo mentore a suo tempo. Con questi risultati e il contratto in scadenza nel 2014, era obiettivamente difficile non rinnovargli la fiducia con un accordo più lungo, eppure i dubbi attorno alla sua figura non si sono placati, ma anzi sono riemersi da più parti proprio in questi giorni, in occasione del rinnovo contrattuale. Non vi nasconderò che anche il sottoscritto era parecchio scettico sulla guida tecnica degli Heat al via della stagione successiva a The Decision, perplessità acuite dal modo in cui quella stagione si è conclusa. Ma parecchi fattori e situazioni delle ultime due ottime stagioni sembrano dimostrare che, invece, la scelta fatta da Miami sia stata azzeccata, e di conseguenza anche quella di continuare su questa strada. Anche prescindendo dal fatto che silurare un allenatore bicampione NBA sarebbe da pazzi, e che iniziare la stagione col coach in scadenza lo è ancora di più, ci sono svariati elementi che giustificano la decisione della dirigenza biancorossa, fruibili anche da molti siti americani cui mi sono appoggiato.
Nel 2008, alla sua presentazione, Riley dichiarò entusiasticamente che Spoelstra era “nato per allenare”; ma una cosa è farlo con dei ragazzotti della Ruhr (dove aveva allenato a inizio carriera prima di approdare, addirittura già nel 1995, nello staff degli Heat) un’altra è dover inserire James nella squadra di Wade e farli coesistere. E la prima stagione dei Big Three lo dimostrò: dopo una gran stagione culminata con la Finale, con Miami avanti 2-1 e in controllo, la squadra naufragò tra difficoltà di adeguamenti tattici (la difesa su Nowitzky restò un rebus per tutta la serie) e ingiustificati cali di tensione, forse per una eccessiva sicurezza dei giocatori sulla vittoria finale, che in effetti pareva piuttosto auspicabile. Lebron e Wade che prendono in giro un influenzato Wunder Dirk prima della decisiva gara 5, finendo per perdere partita e serie, ne è l’esempio perfetto.
All’indomani di una sconfitta arrivata in questo modo, le perplessità sulla gestione di Spoelstra erano più che giustificabili; ma la rinnovata fiducia di Riley, dopo un periodo di grandi dubbi sulla direzione tecnica da intraprendere per questa squadra, oltre a rivelarsi l’ennesima decisione vincente nella grandiosa carriera dell’ex Kentucky, non può che aver fatto bene all’allenatore di origine filippina, che da lì in poi ha sbagliato davvero poco, sia nella non facile gestione di uno spogliatoio come quello degli Heat, sia a livello tattico.
Cominciamo dal primo settore, lo spogliatoio. Spoelstra è noto per essere un gran motivatore, un coach vicino ai giocatori, su cui lavora soprattutto da un punto di vista psicologico. E la qualità del suo lavoro si evince proprio da come sia riuscito ad ottenere il meglio praticamente da tutti i giocatori passati da Miami sotto la sua gestione. Si pensi a gente come Joel Anthony, Miller, Battier, Andersen: per motivi diversi (limiti tecnici, infortuni, problemi personali) pochi si aspettavano l’ottimo impatto che invece hanno avuto in questi anni. Ma il risultato più importante, che ha portato ovviamente i maggiori benefici, è stato riuscire a far cambiare atteggiamento a uno come Lebron James, forse il miglior giocatore del mondo, che sotto Spoelstra è diventato anche un gran lavoratore, ha limitato le derive di gioco individualistico, ha smesso di accontentarsi troppo spesso del tiro da fuori, finendo col migliorare ulteriormente il proprio gioco già devastante, coinvolgendo maggiormente i compagni (e i benefici sono evidenti) e consacrandosi definitivamente come giocatore più determinante della Lega. Se prima, a Cleveland soprattutto, “bastava” cercare di limitare lui per mettere in difficoltà l’intero sistema di gioco, ora è più complicato sia limitarlo che rompere i meccanismi di un gioco che comunque si basa fortemente sull’MVP, ma in maniera completamente diversa. La grande differenza di rendimento e di modo di giocare tra le sue due Finali con gli Spurs (2007 coi Cavs e 2013) mostra quanto sia stata profonda questa evoluzione.
Rimanendo sempre sul Prescelto, un altro aspetto che si tende a sottovalutare è la facilità con cui è avvenuta la transizione della squadra dalle mani di Wade a quelle di Lebron, tutt’altro che scontata. Se D-Wade ci ha messo del suo, accettando intelligentemente un ruolo più secondario a favore dei risultati di squadra, questa transizione è avvenuta sotto la guida di Spoelstra, che ha gestito le difficoltà iniziali (l’inizio nel 2010 fu 9-8) trovando la quadratura del cerchio in fretta, riuscendo poi anche a risolvere nel migliore dei modi alcune tensioni che, in alcune situazioni di difficoltà, si vennero a creare (vedi gara 3 coi Pacers nei playoff del 2012, in cui gli Heat sembrarono sul punto di implodere ma finirono per vincere serie e titolo). La coesistenza e le gerarchie con tre All Star in spogliatoio sono tutt’altro che semplici, eppure a Miami le frizioni sono state poche e il meccanismo ha quasi sempre funzionato; la mano dell’head coach non può esserne esente.
Passiamo ora a qualche considerazione tattica. Per prima cosa, è evidente che Spoelstra si sia ormai affermato come uno dei migliori coach difensivi della Lega, in grado di costruire un’ottima organizzazione difensiva per i suoi Heat, i quali, nonostante il talento offensivo infinito, vincono soprattutto alzando la radio nella propria metà campo, non solo perché subiscono meno, ma soprattutto perché così facendo si genera il letale contropiede degli Heat. Quindi a difesa efficace equivale un attacco irresistibile, una combinazione praticamente impossibile da fermare.
Tatticamente parlando poi, Spoelstra ha dimostrato sul campo di riuscire ad adattarsi alle caratteristiche dell’avversario e a far fronte alle difficoltà, spesso anche costringendo gli avversari a snaturarsi. Ha subito molto il gioco basato sui lunghi di Indiana, ma ha risposto mettendo forte pressione sugli esterni dei Pacers, che non sono buoni trattatori del pallone, annichilendo così l’attacco avversario. La passata stagione, in Finale, ha surclassato tatticamente uno come Scott Brooks, già Coach of the year e allenatore preparato: dopo aver perso gara 1, si è adeguato di conseguenza e ha vinto quattro partite consecutive aprendo il più possibile il campo e giocando piccolo, mettendo anche il centro (Bosh o Haslem) in posizione quasi perimetrale e costringendo i Thunder a snaturarsi rinunciando a uno dei loro lunghi di ruolo (Perkins o Ibaka), usando per più tempo del previsto Durant da ala grande, posizione che non predilige troppo, e scombinando così anche gli accoppiamenti difensivi di OKC (se Sefolosha marca Lebron, chi marca gli altri tre esterni?). Un’idea simile l’ha ripetuta in questa Finale contro il mostro sacro Gregg Popovich, anch’egli costretto a togliere un’ormai inutile Splitter, con la differenza che sotto rimaneva Duncan, non Ibaka, e che quindi gli Spurs rimanevano offensivamente pericolosi anche vicino al ferro. Se dunque con OKC Miami ha subito poco in area e ha controllato piuttosto facilmente la serie, con gli Spurs ha fatto più fatica e ha avuto bisogno di una buona dose di fortuna per vincere. Ma che Spoelstra sia riuscito a piegare almeno in parte Popovich verso il proprio gioco è un dato di fatto: se nelle ultime stagioni gli Spurs erano già diventati una squadra che si affidava molto al tiro dalla lunga (eresia per il primo Pop, ma i tempi cambiano), questa tendenza si è esasperata con lo “small ball” imposto dagli Heat. Finchè San Antonio ha tirato con percentuali molto alte (prime 5 gare) ha controllato la serie, poi, pur lottando, l’ha persa. Se non si può dire che Spoelstra abbia battuto tatticamente il grande Pop, sicuramente non ne è uscito sconfitto come molti suoi colleghi prima di lui.
Conclusioni: Spoelstra è un fenomeno o è sopravvalutato e agevolato dalla quantità industriale di talento che si ritrova in squadra? Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, e ancora una volta la verità sta probabilmente nel mezzo. I suoi successi sono dovuti anche ad assistenti di ottimo livello (su tutti Bob MacAdoo e David Fizdale) e talvolta ha avuto anche una buona dose di fortuna (oltre alla già citata Finale scorsa, emblematica è gara 6 contro i Celtics dei playoff 2012, nella quale se non fosse stata per una prestazione fuori dal mondo di James ora probabilmente parleremmo di Spoelstra in tutt’altri termini, e sicuramente da ex coach degli Heat), che comunque, si sa, aiuta gli audaci. Inoltre molte scelte tattiche, in particolare quella sorta di “small ball” che è ormai il marchio degli Heat, sono possibili solo avendo un giocatore che gioca lungo in difesa e play in attacco come Lebron, che ti permette di non subire troppo fisicamente e a rimbalzo e di attaccare poi con quattro esterni puri. Nessun altro, ovviamente, può permettersi un lusso simile. Ma prima di approdare a Miami, Lebron ha fatto 7 stagioni senza vincere nulla, alcune delle quali anche con ottime squadre, risultando arma tattica importante ma non così devastante. E se si parla di talento totale degli Heat, certo agevola molto l’allenatore, ma quante squadre con roster sulla carta favolosi hanno deluso le aspettative? Senza andare troppo lontano, si possono citare i Lakers della passata stagione, che al contrario di Miami non hanno mai trovato la quadratura del cerchio: su questo la direzione tecnica pesa eccome. Persino uno come Phil Jackson, che ha più anelli che dita, nel 2003 ha perso un titolo con 4 futuri Hall of Famer in campo (5, considerando anche lui stesso); quindi il talento è fondamentale, ma non sempre vince i titoli senza una guida che lo sappia utilizzare nella giusta maniera.
Spoelstra non è un fenomeno, e forse Riley è stato troppo entusiastico nel dire che è nato per allenare: lo dimostrano, ad esempio, i blackout che spesso colpiscono ancora i suoi Heat. Ma è un buonissimo allenatore che ha saputo trarre il massimo dalle ottime basi che gli sono state fornite, sfoderando un carisma inaspettato che gli ha permesso di far funzionare il tutto senza che implodesse, e questo è dimostrato dal fatto che, quando Miami gioca con continuità la propria pallacanestro fatta di difesa e contropiede, è difficilmente battibile (27 vittorie consecutive non sono casuali). Miami ha dunque proseguito con lui, perché comunque non avrebbe trovato sul mercato un coach migliore e perché probabilmente, tutto sommato, Spoelstra è l’allenatore adatto per questa squadra. Che ora avrà dunque la possibilità di superare il maestro, concludendo uno storico three-peat. Difficile che Riley possa prendersela troppo a male…
SEGUITECI SU FB: https://www.facebook.com/NbaReligion
SEGUITECI SU TWITTER: https://twitter.com/NbaReligion