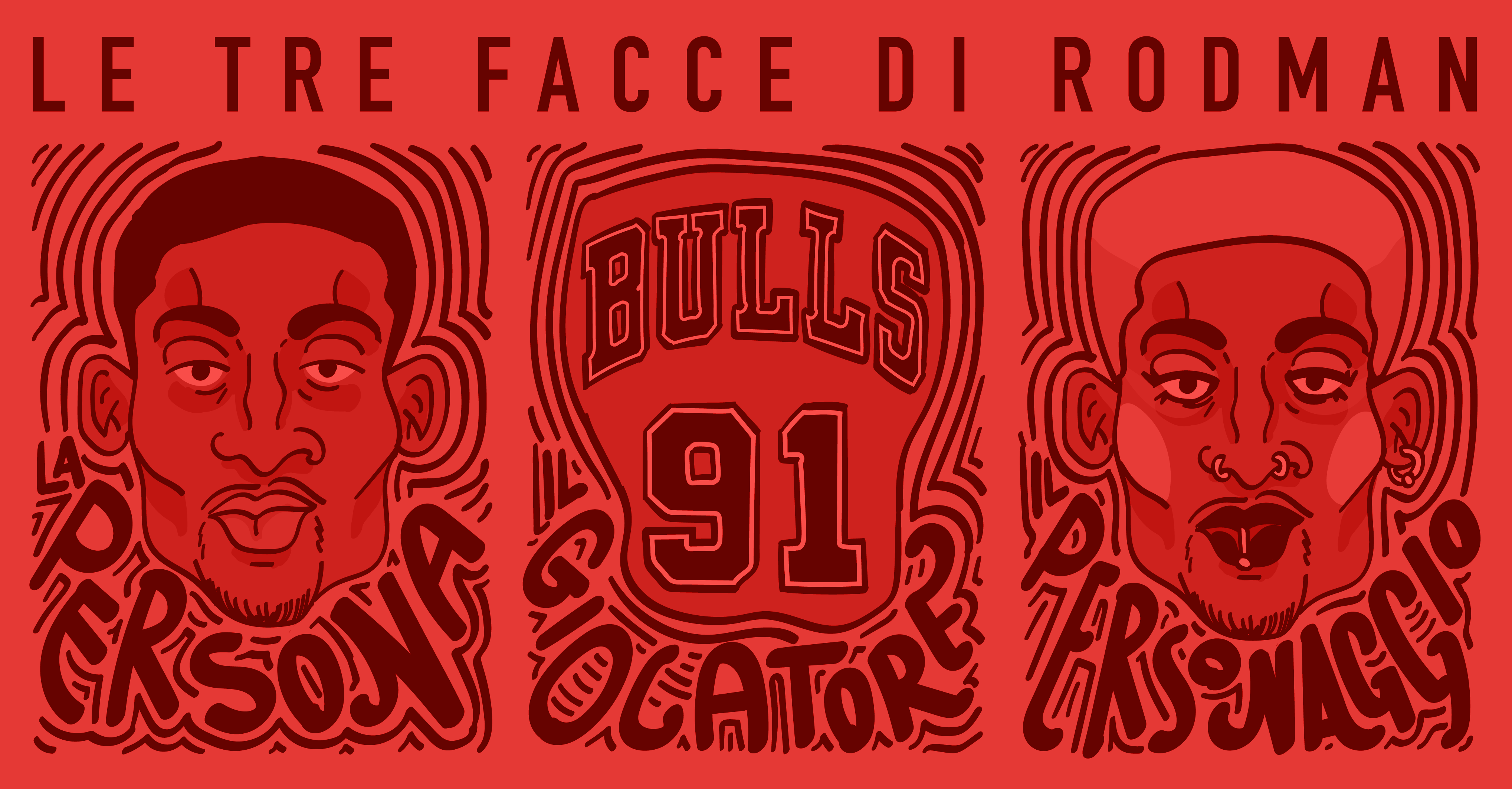Se doveste avere, o magari abbiate già avuto, la fortuna di assistere dal vivo a una partita NBA in un palazzetto d’oltreoceano (lo Europe Live a confronto è una partitella tra scapoli e ammogliati) la cosa che vi colpirebbe maggiormente, al di la del livello e dell’intensità più variabili del Dow Jones soprattutto per quanto riguarda la regular season, sarebbe molto probabilmente l’atmosfera che si respira, l’elettricità che comunque attraversa l’aria, una sensazione difficilmente descrivibile e inimmaginabile nei nostri palazzetti, peraltro lontani anni luce. Tra le tante arene storiche che possiamo trovare attraversando gli States da un oceano all’altro ce n’è una in particolare in cui il calore dei tifosi e la temperatura torrida che si viene a creare nelle partite che contano non è eguagliata da nessun’altra parte. Il Madison? Il Garden? Lo Staples, erede del leggendario Forum? Acqua, fermo restando che anch’essi sono templi unici, per motivi diversi. Si tratta invece della Sleep Train Arena di Sacramento, casa dei Kings. Chiaro che ultimamente non c’è molto di cui felicitarsi da quelle parti, e che anche l’umore della tifoseria si è inevitabilmente raffreddato negli ultimi anni di vacche cronicamente anoressiche, ma quando le vacche ancora si abbuffavano allegramente questo posto, con il nome di ARCO Arena, era l’incubo di più di qualche giocatore. Soprattutto nei playoff, quando appunto ancora si facevano, l’Arena raggiungeva decibel che nemmeno i Metallica si sognavano, grazie all’usanza di suonare incessantemente dei campanacci simili a quelli al collo dei bovini in montagna, al cui confronto il suono delle vuvuzela ricorda quello dell’arpa, creando così un’atmosfera infuocata che rendeva impresa ardua per gli avversari il solo scendere sul parquet.
Difficile pensare che il tifo influisca così tanto? Basta un dato: nel ’91 i Kings chiusero con un buon 24-17 in casa e un incredibile 1-40 fuori, impresa mancata persino ai leggendari Sixers del ’73 che on the road ne vinsero il doppio. Ma prima di giungere in questa bolgia legalizzata gli attuali Kings ne hanno fatta di strada, più di qualsiasi altra franchigia, letteralmente parlando. La sua antenata primigenia risale addirittura agli anni ’20, e scusate se è poco, aveva sede a Rochester e si chiamava Seagrams dall’azienda che cacciava la grana, la quale fortunatamente cambiò il nome in Royals a fine ’40. Non tutti lo sanno, ma questi fantomatici Royals figurano come la quinta vincitrice della giovane National Basketball Association, nell’anno di grazia 1951; da lì in poi solo pianto e stridore di denti girovagando l’America, prima Cincinnati, poi Kansas City e il cambio di nome per non urtare gli omonimi colleghi del Diamante, approdando infine nella capitale della California (perché sì, Sacramento è inspiegabilmente la capitale, non LA o San Francisco), a metà anni ’80. Canonici dieci anni di abbonamento alla Lottery e finalmente arrivano i playoff nel ’96, per la gioia degli scatenati sostenitori sugli spalti.
Mitch Richmond è l’eroe dei primi playoff cittadini, unico re dei Re. Ovviamente i Sonics del Guanto e Kemp li mandano a casa bagnando appena le canotte di sudore.
Anno nuovo vita vecchia, niente playoff, nonostante altri 5 in doppia cifra media oltre a Mitch, copione che si ripete anche nel ’98, stavolta a dispetto anche di un Corliss Williamson da 17 a sera. La dirigenza allora fa partire la rivoluzione copernicana: il draft alla 7 regala un piccoletto che sembra più adatto all’And One Mixtape che ai pro ma che farà vedere cose uniche e mai più viste su un campo come Jason Williams, l’ampio spazio sotto il cap viene usato per un centrone serbo di grande tecnica ed esperienza come Vlade Divac, e soprattutto l’idolo Richmond viene sacrificato per arrivare al più rappresentativo dei Fab Five di Michigan (e non che gli altri fossero proprio gli ultimi broccacci), quel Chris Webber costretto a relegare una classe senza pari in un fisico troppo fragile. Non contento, il GM Geoff Petrie fa un paio di telefonate intercontinentali per farsi mandare dalla Grecia quel ragazzotto slavo che rilascia la palla come Ray Allen, ma un buon mezzo metro più in alto tra altezza e braccia, che hanno scelto due anni prima e hanno lasciato in Europa a maturare; dopo una stagione da mvp del campionato greco Peja Stojakovic sembra pronto per il grande salto, e allora via sul primo volo per la California. La proverbiale ciliegina su questa bella torta la mette il nuovo coach Rick Adelman e la sua intuizione di chiamare come assistente un vecchio allenatore di college mai approdato al piano di sopra, ma che nella sua Princeton ha messo su un sistema di gioco niente male: è Pete Carril, entrato addirittura nella Hall of Fame per aver inventato appunto il Princeton Offense.
Finalmente i “bovari” (come sovente vengono definiti i tifosi sugli spalti dagli avversari che li adorano) hanno una squadra degna di questo nome per cui suonare i loro campanacci: girano perfettamente, vincono, convincono e divertono pure. Perché il sistema di gioco da Princeton non è tra i più semplici mai ideati e presuppone interpreti particolari per farlo funzionare al meglio (soprattutto tra i lunghi), ma è in grado di generare un gioco fluido e veloce, con grande movimento di palla e il coinvolgimento offensivo di tutti i giocatori. E in California gli interpreti di Adelman sono perfetti: Divac e Webber sembrano nati per questo attacco, la coppia Williamson-Stojakovic è perfettamente complementare, la panchina è già una della più lunghe in circolazione e a dirigere il tutto in cabina di regia c’è il White Chocolate, che fa da coronamento ad un attacco efficace ma anche spettacolare che manda in visibilio non solo l’ARCO Arena ma l’intera Lega.
Purtroppo però secondo un detto NBA raramente smentito l’attacco ti può far vendere biglietti, ma è la difesa a farti vincere i titoli, e questi sì e no che sappiano di avere una metà campo difensiva. Di conseguenza, se in stagione regolare riescono a sopperire con lo strabordante talento, quando conta pagano regolarmente dazio, e per due anni di fila non riescono ad andare oltre un misero primo turno: nel ’99 tornano ai playoff con la sesta moneta, che equivale ai Jazz campioni uscenti a Ovest, i quali soffrono la dinamicità della giovane squadra emergente e probabilmente anche gli strascichi mentali di The Shot di quasi un anno prima ma riescono comunque a liquidare i californiani in 5 gare. Stesso destino che si concretizza anche nella stagione successiva, con l’ottava posizione e primo incrocio con un’avversaria che rivedranno loro malgrado, quei Lakers rigenerati dai contemporanei arrivi del Diesel e di un liceale da Philadelphia i quali si apprestano a riportare i gialloviola sull’Olimpo della Lega. Nonostante il passo indietro in stagione regolare comunque i Kings mostrano maggiore maturità nella post season portando la numero 1 del ranking alla decisiva gara5, dove devono alzare bandiera bianca.
Nell’off season 2000 dunque i Kings sono la più classica delle squadre né carne né pesce: hanno qualità più che sufficiente per fare i playoff e non andare alla Lottery ma non abbastanza per giocarsela seriamente con le corazzate a sinistra del Mississippi. E’ evidente che qualcosa va cambiato, come è altrettanto evidente che serva più sostanza nella metà campo difensiva. Detto fatto: Williamson, che con la sua totale assenza di tiro dalla lunga e la crescita di Stojakovic, che ha caratteristiche opposte e ben più adatte alla Princeton, è l’elemento più facilmente sacrificabile e fa quindi le valigie per il Canada, direzione Toronto. Percorso inverso lo compie Doug Christie, che sembra creato in laboratorio per rispondere alle esigenze dei viola: ottimo difensore sulla palla, tutt’altro che attaccante inarrestabile ma dotato di un mortifero piazzato da fuori, come il credo di Carril esige. Discorso identico vale per Bobby Jackson, prelevato dal Minnesota per fare il cambio disciplinato all’imprevedibile Williams. Ad allungare una panchina già lunghissima ci pensa poi il draft che con la scelta numero 16 porta in dote un’ala europea fotocopia di Stojakovic ma potenzialmente più completa: è il primo turco a calcare un parquet NBA, al secolo Hidayet Turkoglu.
Apoteosi. Si scollinano le 50 vittorie stagionali (55-27, terzo posto nell’agguerritissima Western), grazie a una difesa non certo insuperabile ma che perlomeno non imbarca più tanta acqua quanta il Titanic. Di la, il Princeton Offense mostra i suoi risultati migliori: Webber chiude a 27 di media ed è forse il miglior lungo offensivo dopo Shaq, Stojakovic esplode e chiude anch’egli a 20 a sera, sfiorando il Most Improved. Il quintetto è spettacolare sotto ogni punto di vista, tanto da finire in copertina su Sports Illustrated con annesso “The Greatest Show on Court” come titolo, ed ogni singolo elemento di questi cinque ha un buon cambio in panca (rispettivamente Jackson-Barry-Turkoglu-Fanderburke-Pollard, nessun fenomeno ma tutti ottimi elementi dal pino). I Kings sono ormai una squadra temibilissima per chiunque, forse una contender. Eppure…
…eppure nada anche stavolta. Primo turno agevole coi Suns, liquidati in 4 gare, sotto coi rivalissimi losangelini, ovviamente gialloviola (al tempo le parole “Clippers” e “playoff” stavano nella stessa frase solo nelle barzellette), che partono favoriti in una serie che comunque si prospetta combattuta. Non lo sarà: secco 4-0, ARCO umiliata in gara3 (-22) da una squadra che comunque perderà solo una partita in tutti i playoff. Resta la consapevolezza di aver perso con i migliori, ma lo smacco è troppo pesante per una società ormai consapevole di poter arrivare in fondo perché si volti tranquillamente pagina con vino e taralli per tutti.
A pagare dazio è un giocatore che veder lasciare la tua squadra può far piacere quasi quanto una cartella esattoriale nella posta. Stavolta infatti la spada di Damocle dell’esilio canadese cade sull’idolo dei tifosi, uno che pur rendendoti conto dei grossi limiti che presenta sulle due metà campo obiettivamente non puoi non amare per quello che fa e per come lo fa. Jason Williams, il Cioccolato Bianco che aveva deliziato una città e un paese intero con i suoi passaggi di gomito, parte suo malgrado per Vancouver, da cui poi seguirà l’intero baraccone nel trasferimento a Memphis, avvenuto proprio quell’estate. Il posto al sole in California va dunque a Mike Bibby, molto meno dionisiaco ma tremendamente più apollineo, meno show e più concretezza. Soprattutto tiratore di gran lunga superiore, che è quello che Carril richiede, e pazienza se ha meno doti di playmaking puro, che in un gioco tutto tagli e tiro servono relativamente.
Giacomo Sordo