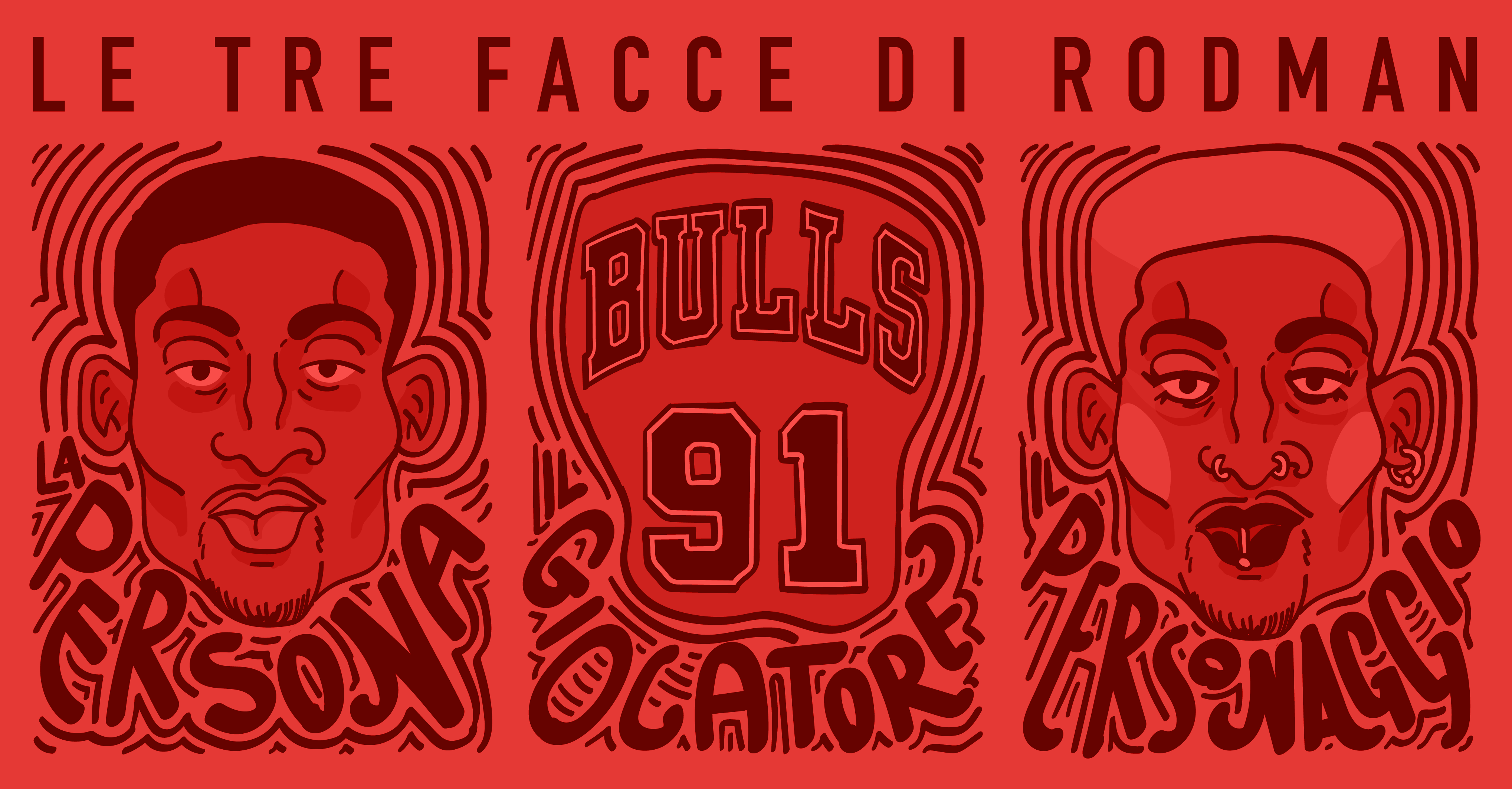«Ho messo a punto un’idea nuova: quattro punte. Sembra folle, ma non lo è. Si muovono in verticale, a rombo. Il fantasista, dietro, porta palla e le tre punte vicinissime per i triangoli stretti e per i fraseggi. Si ha un uomo in più in attacco. Si possono vincere le partite così.»
Queste sono alcune delle parole che Paolo Sorrentino, al suo esordio alla regia, mette in bocca ad Andrea Renzi nel ruolo di Antonio Pisapia; ex calciatore con il sogno, mai realizzato, di diventare allenatore.
Pisapia, un po’ Ezio Glerean un po’ Agostino Di Bartolomei, acciuffa quattro tazzine da caffè in un bar della Napoli disillusa e ben poco folkloristica degli anni ’80, pone le mani su di esse e le muove provando a spiegare a un poco interessato direttore sportivo la sua idea di calcio.
Un’intuizione nuova appunto, quasi rivoluzionaria, che prevede un gioco incredibilmente offensivo con una spregiudicata superiorità numerica nella zona d’attacco. Intuizione, ahilui, purtroppo destinata a rimanere tale.
È il 10 Novembre al Verizon Center di Washington e mancano 56 secondi al termine del primo tempo. Kevin Durant riceve palla all’altezza della linea di metà campo e, con la solita grazia e leggiadria, s’invola verso il canestro. Due palleggi secchi e si libera di John Wall, raccoglie il pallone, terzo tempo e si eleva verso il ferro, dove trova Kris Humphries ad attenderlo. In una situazione normale sarebbero probabilmente 2 punti con tiro libero supplementare, invece Durant sbaglia il facile appoggio a canestro e, scendendo da un’altezza inimmaginabile per un normodotato, si tocca il ginocchio sinistro.
Segna i due tiri liberi conseguenti al fischio dell’arbitro e trascorre in campo i pochi spiccioli di parziale che restano. Da quel momento però non rientra più sul parquet: problema al tendine del ginocchio sinistro e stop forzato di almeno una decina di giorni.
Poca roba, in realtà, se paragonata alle tre operazioni subìte al piede destro nella stagione passata, che l’hanno costretto a saltare ben 55 partite (e a vedere da bordocampo i suoi Thunder impegnati nel tentativo, fallito, di acciuffare l’ultimo posto disponibile per la postseason). Eppure sempre di un periodo lontano dal parquet si tratta, proprio in una stagione che minaccia di essere uno spartiacque e per Durant e per Oklahoma City e per l’NBA intera.
Le premesse, in tal senso, sono chiare ed evidenti. I Thunder hanno vinto 266 partite negli ultimi 5 anni, secondi in questa statistica solo a quegli highlanders che rispondono al nome di San Antonio Spurs.
Tuttavia, per una serie interminabile di circostanze e coincidenze, non sono ancora riusciti a centrare quell’obiettivo che già a partire dal 2009 appariva scontato e che ora diventa quasi necessità insopprimibile: il titolo NBA.
Nel 2012 si sono messi di mezzo la relativa inesperienza e LeBron James; nel 2013 i sogni s’infrangono nel momento in cui Patrick Beverley rovina sul ginocchio di Russell Westbrook; nel 2014 è il turno del polpaccio di Ibaka e, infine, nel 2015 il piede destro di Durant impedisce persino l’accesso ai playoffs.
Oggi Kevin Durant ha 27 anni, si affaccia al picco delle proprie possibilità di rendimento psicofisico e si trova a esprimersi all’interno del contesto sicuramente più competitivo avuto a disposizione da quando ha messo piede nel basket dei grandi. Eppure (sì, c’è un eppure) qualcosa sembra sempre non funzionare come dovrebbe.
Kevin ha perso il sorriso – se mai l’ha avuto – cosa già evidente a partire dal media day di quest’anno. Il ragazzo è schivo, battibecca via Twitter con Stephen A. Smith e, più in generale, evita la stampa; come se qualcosa, dentro di lui, dopo quelle 55 partite saltate per infortunio, si fosse rotto per sempre. Un atteggiamento contro natura per uno che è sempre riuscito a creare grande empatia attorno a sé; basti pensare al discorso di ringraziamento tenuto durante la consegna del premio di MVP, con il quale ha commosso tutti gli Stati Uniti.
La lunga assenza dal parquet sembra averlo indurito, intristito; d’altronde come potrebbe essere altrimenti per chi, come lui, è abituato a nutrirsi, corpo e anima, di sola pallacanestro?
Russell Springmann – ex assistente-allenatore alla University of Texas – ricorda che, durante l’estate successiva alla sua stagione da rookie, Kevin ha dormito su un materasso ad aria (di quelli da spiaggia, per intenderci) nell’appartamento del suo compagno Justin Mason, solo per essere più vicino alla palestra al mattino: «Because that’s Kevin Durant!»
Ecco, ora immaginate di avere questa propensione naturale verso una qualsivoglia attività e di passare svariati mesi senza potervi nemmeno alzare dal divano se non con l’aiuto di qualche anima pia. Non bellissimo, vero?
Tuttavia, alla base di quest’ermetismo, di quest’asserragliarsi dietro un muro di silenzi degno del miglior Roger Waters, credo ci sia dell’altro.
I primi indizi giungono, ancora una volta, dal media day. Michael Cage organizza un’intervista congiunta con Durant e Russell Westbrook, ma c’è un problema: un solo sgabello a disposizione. I due si guardano e alzano le spalle.
Niente di che, ma eccoci di nuovo a quel 10 Novembre a Washington.
Una serata di certo non normale per Kevin Durant, che torna a casa sua proprio in un momento in cui le voci di mercato si alzano sempre più forti, voci che lo vorrebbero figliol prodigo a D.C. al termine della stagione (nel 2016 infatti Kevin sarà free agent).
Durant gioca, si fa male, ma i suoi vincono lo stesso di 24 punti; la firma, una volta di più, è quella di Russell Westbrook: tripla doppia da 22 punti, 11 rimbalzi e 11 assist.
Al di là dei numeri e delle statistiche, una cosa mi colpisce in particolare: la continuità con la quale Westbrook si carica la squadra sulle spalle. È evidente ormai: lo stop di Kevin ha determinato un passaggio di consegne. La leadership dei Thunder è nelle mani del numero 0, che se l’è presa a suon di triple doppie. Westbrook ha sempre la palla in mano, l’ultimo tiro è sempre suo, le situazioni tattiche prevedono sempre Westbrook come pivotal player.
È in quel preciso momento che le parole di Renzi/Pisapia soggiungono alla mia mente. La filosofia dell’uomo in più, che Ezio Glerean ha applicato al suo calcio di provincia – ma che mai è arrivata a quello che conta – ben aderisce alla situazione di Kevin Durant.
L’uomo in più dei Thunder altri non è se non lui, dopo una stagione passata sulla sideline; ma Durant è tanto “di più”, forse, da risultare quasi di troppo in una squadra che pare aver tacitamente nominato un altro leader.
Una guida più eccentrica, caratterialmente agli antipodi, che si presenta alle partite in pantaloni di pelle e mise stravaganti, senza zainetto con dentro la bibbia. Quel Russell Westbrook perfetta proiezione dell’altro Pisapia di Sorrentino: Tony (interpretato da uno splendido Servillo); cantautore debosciato, solo e cocainomane, ma anche uomo che affronta la vita di petto e che, in un monologo d’intensità shakespeariana, si dichiara uomo libero a cui “non è mai fregato un cazzo di nessuno”.
Due binari paralleli quelli di Kevin Durant e Russell Westbrook nella vita reale, proprio come quelli di Antonio Pisapia/Di Bartolomei e Tony Pisapia/Franco Califano sulla pellicola.
Per quest’ultimi Sorrentino ha progettato una convergenza drammatica, segnata da eventi tragici. Un suicidio, una vendetta, in cui tutto ciò che resta “in più” è la sconfitta, tratto unificatore dei due personaggi.
I binari di Durant e Westbrook non si sono ancora incontrati, ma il tempo e le circostanze giocano a loro favore. Si tratta solo di appianare le differenze, ricercare un equilibrio, cominciare finalmente a giocare assieme per il bene di entrambi, dei Thunder e dell’NBA tutta.
Sullo sfondo una free-agency, quella del 2016, che rischia di lasciare tutti sconfitti, di nuovo.
Antonio Pisapia, Tony Pisapia, Agostino Di Bartolomei, Franco Califano erano l’uomo in più, ma si sono sentiti di troppo e per questo hanno perso.
Kevin Durant e Russell Westbrook sono entrambi “in più” e, in quanto tali, di più sono chiamati a fare rispetto alle proprie controparti cinematografiche. Le possibilità di evitare la sconfitta e, insieme, di raggiungere finalmente l’agognato titolo NBA sono tutte davanti a loro, basta solo allungare la mano e afferrarle.
Ma d’altronde, si sa, alla fine la verità è questa.